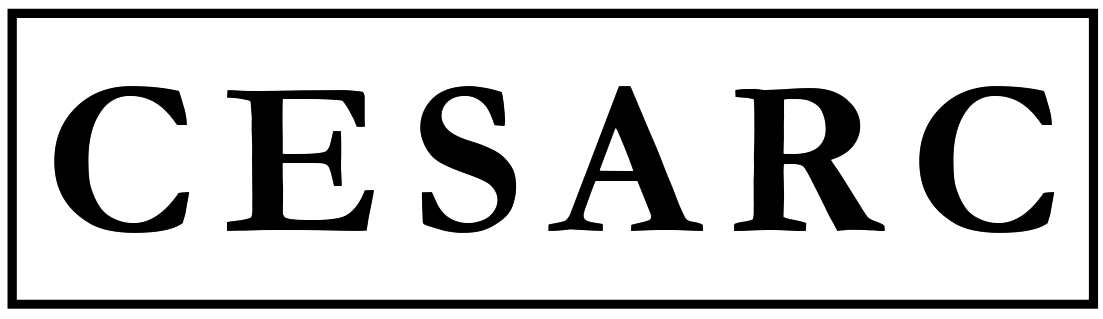Sergej Petrov
Avviata la procedura del progetto di legge che porterebbe all’uscita della Russia dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura.
Le contraddizioni di un sistema che da un lato inasprisce le pene per l’abuso di potere, dall’altro legittima la violenza di Stato. Le giovani generazioni cresceranno in un sistema che ha trasformato la tortura in uno strumento ordinario di governo.

La rottura tra la Russia e le istituzioni europee che si occupano dei diritti umani si è consumata rapidamente dopo l’aggressione all’Ucraina: il 25 febbraio 2022 Strasburgo ha sospeso la Russia dal Consiglio d’Europa sulla base dell’articolo 8 dello statuto, avviando la procedura di espulsione e ignorando il recesso volontario (art. 7) espresso successivamente da Mosca, che ha accusato l’UE di aver trasformato il Consiglio in strumento «anti-russo». Di conseguenza, la Russia ha cessato di far parte anche della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), benché la Corte europea mantenga giurisdizione per i fatti precedenti al 2022, secondo il principio di continuità legale.
Gli effetti sono già drammaticamente concreti: i cittadini russi hanno perso l’accesso alla giustizia internazionale europea per le nuove violazioni, mentre si va chiudendo definitivamente quello spazio comune umanitario e legale che paradossalmente la stessa Russia ha invocato nelle sue dichiarazioni ufficiali.
A differenza della CEDU, la Convenzione per la prevenzione della tortura (ECPT) è un trattato separato, sebbene strettamente collegato agli obiettivi del Consiglio d’Europa. Il meccanismo centrale di questa convenzione è costituito da un organo di esperti (CPT) che ha il potere di condurre visite senza preavviso nei luoghi di detenzione all’interno di uno Stato, allo scopo di verificare le condizioni di detenzione, comunicare con i detenuti e formulare eventuali raccomandazioni alle autorità locali. Dato che l’espulsione dal Consiglio d’Europa non comporta automaticamente la cessazione immediata di tutti gli obblighi, la Russia è rimasta vincolata alla Convenzione (sottoscritta nel 1996 e ratificata due anni dopo), ma per il Cremlino questo residuo di controllo internazionale sulle condizioni carcerarie è diventato sempre più insopportabile.
Tra il 2001 e il 2024 il CPT ha emesso cinque dichiarazioni pubbliche contro la Federazione russa (relative soprattutto a episodi perpetrati in Cecenia), un fatto significativo poiché si tratta di uno strumento usato solo quando un paese non coopera. L’organismo europeo ha cercato di mantenere un dialogo costruttivo con le autorità russe per riprendere le visite di monitoraggio, ma ha dovuto affrontare «la persistente mancanza di cooperazione», come nel caso della morte di Naval’nyj.
Da parte sua, la Russia ha lamentato di non essere più rappresentata nel CPT dal dicembre 2023, dato che l’UE ha bloccato la nomina di un suo nuovo rappresentante al termine del mandato precedente, «e non ha la possibilità di partecipare a pieno titolo e in modo completo ai lavori di monitoraggio». Così all’inizio di settembre, con il sostegno del governo, il presidente Putin ha trasmesso alla Duma il progetto di legge che porterebbe all’uscita dalla Convenzione.
Ol’ga Sadovskaja, vice responsabile del Comitato contro la tortura (organizzazione russa informale per i diritti umani, «agente straniero» dal 2015), ha osservato in un’intervista (https://youtu.be/ssMmEH2-lOI ) che si tratta di una decisione che «completa il processo di smantellamento del sistema europeo di controllo sul rispetto dei diritti umani», privando «i cittadini russi detenuti dell’ultima forma di protezione internazionale». Ma sarebbe riduttivo interpretare questo gesto come mera conseguenza della guerra: rappresenta piuttosto l’esito di una deriva autoritaria che affonda le radici in decenni di tolleranza verso la violenza commessa dalle istituzioni.
La tortura in Russia non costituisce un’aberrazione occasionale, bensì un fenomeno strutturale che attraversa la storia del paese con inquietante continuità, come emerge dalle testimonianze raccolte dal progetto Gulagu.net grazie al coraggio di Sergej Savel’ev, un ex detenuto che ha avuto accesso alle videoregistrazioni dei sistemi di sorveglianza delle colonie penali; dai suoi materiali documentari emerge che la pratica della tortura non capita episodicamente ma è un vero e proprio sistema di violenza organizzata e sistematica.
Costruire un bunker lasciando le chiavi nella toppa
La continuità storica con l’epoca sovietica è innegabile: già nel sistema staliniano gli investigatori dovevano estorcere confessioni, e le guardie che accompagnavano i prigionieri perpetravano violenze apparentemente gratuite ma funzionali al mantenimento di un clima di terrore. La differenza sostanziale sta nella capacità dell’apparato contemporaneo di nascondere sistematicamente le proprie pratiche, creando una facciata di legalità che rende più difficile la denuncia e la documentazione.
Inoltre, il problema non risiede tanto nell’assenza di norme quanto nella loro applicazione pratica, tant’è vero che il 22 giugno scorso la Duma ha approvato una legge che inasprisce significativamente le pene per i funzionari pubblici che si rendono colpevoli di tortura. Il provvedimento, presentato dai presidenti dei comitati per la legislazione delle due camere del parlamento, Andrej Klišas e Pavel Kraševinnikov, rappresenta una risposta legislativa agli scandali emersi nel sistema penitenziario federale. Kraševinnikov ha sottolineato che i soprusi sui detenuti e l’umiliazione della loro dignità «non possono essere giustificati da nessuna buona intenzione dei funzionari delle forze dell’ordine e da nessuno scopo socialmente significativo».
La riforma interviene principalmente sugli articoli 302 (coercizione alla testimonianza) e 286 (abuso di potere) del c.p.: ora le torture organizzate e condotte da rappresentanti statali sono punibili con la reclusione fino a 12 anni (in casi gravi fino a 15, con interdizione dai pubblici uffici fino a 20 anni), facendole rientrare così nella categoria dei reati particolarmente gravi. La legge introduce anche una definizione più precisa del concetto di tortura, allineandola alla Convenzione adottata dall’ONU (https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-contro-la-tortura-ed-altre-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-1984) nel 1984 (non deve stupire che la Russia avvii l’iter per ritirarsi dalla Convenzione europea, rimanendo però formalmente parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, visto che nel relativo Comitato siede il giurista Bachtijar Tuzmuchamedov, un funzionario strettamente legato al Ministero degli Esteri e alle forze di sicurezza russi).
Allo stesso tempo però l’art. 286 precisa che «non costituisce tortura l’infliggere sofferenze fisiche o morali che derivino da azioni legittime di funzionari pubblici o che siano inevitabilmente connesse a tali azioni»: una clausola che, sotto le spoglie della precisione giuridica, apre uno spiraglio interpretativo tanto ampio quanto inquietante e che rischia di svuotare di significato l’intera riforma legittimando proprio l’abuso di potere, e facendo passare l’idea che esistano sofferenze «legittime» e «illegittime», determinate non dalla loro intensità o natura, ma dalla presunta legalità delle azioni che le causano. Chi stabilisce cos’è «legittimo»? Chi determina cosa sia «inevitabilmente connesso» alle azioni dei funzionari?
La contraddizione è stridente: da un lato si aumentano le pene, dall’altro si crea uno spazio di ambiguità che potrebbe rendere tali pene applicabili solo nei casi più eclatanti. Eppure, quella stessa Convenzione dell’84, all’articolo 2, stabilisce che «nessuna circostanza eccezionale» può essere invocata per giustificare la tortura.
Come sottolinea Sadovskaja, «il tratto distintivo della tortura è che viene commessa o da agenti dello Stato, o per loro incarico, o con la loro tolleranza». Questa caratteristica la distingue da altre forme di violenza: non c’è niente di casuale, non può essere improvvisata: «Puoi uccidere accidentalmente, ma non puoi torturare accidentalmente. La tortura è sempre mirata, c’è uno scopo preciso».
Nel contesto russo questo scopo si manifesta principalmente attraverso due obiettivi: costringere alla confessione di crimini (commessi o meno) e ottenere informazioni su terzi. Ma la tortura assolve anche a una funzione più sottile e pervasiva: quella di sottomettere e umiliare, stabilendo una gerarchia di potere assoluta tra chi detiene l’autorità e chi ne è sottoposto.
La tortura – osserva ancora la giurista, – rivela la natura autodistruttiva del sistema autoritario: nel tentativo di mantenere il controllo attraverso la violenza, esso contamina e degrada i suoi stessi agenti. L’efficacia di questa tecnologia di potere è dimostrata da un esperimento che ha condotto presso l’Accademia del Ministero degli Affari Interni. Ai corsi di aggiornamento per agenti di polizia, alla domanda se fosse lecito usare metodi illegali e torture per ottenere informazioni, al primo anno rispondeva affermativamente il 18% degli studenti. Al quinto anno, la percentuale saliva a oltre il 50%. «Non sono stati educati così in famiglia» – ha concluso, – ma dallo stesso sistema che li stava preparando.
Sadovskaja vede nell’evoluzione del sistema repressivo un problema di responsabilità generazionale: «È stata la mia generazione a permettere che, inizialmente, si potessero rapire persone in Cecenia, (…) poi è stato possibile rapire e uccidere i difensori dei diritti umani che aiutavano le persone rapite in Cecenia (…). Poi lo si è potuto fare nelle regioni vicine, e infine è diventato possibile farlo ovunque».
La generazione di cui parla – i quarantenni di oggi – è la prima cresciuta in un paese che ha beneficiato dell’apertura post-sovietica ma ha trascurato la vigilanza democratica: «Davanti a noi si sono aperte moltissime opportunità fuori e dentro il paese, siamo rimasti così sbalorditi da questa ondata di novità che abbiamo dimenticato di guardare sotto i nostri piedi, su cosa poggiavamo». La lezione che emerge da questa analisi travalica il caso specifico russo: la protezione dei diritti fondamentali richiede una vigilanza costante e sistematica, e «se non ti sei mai interessato ai diritti umani non hai alcuna garanzia che nella tua regione troverai dei difensori quando avrai bisogno di aiuto». Secondo la giurista l’applicazione della tortura costituisce la cartina di tornasole per l’intero sistema dello Stato di diritto, in quanto «se il tuo diritto fondamentale non è protetto, nessun altro diritto meno importante ti è più garantito».
E in situazioni estreme la questione non è se sia lecito torturare, ma quali conseguenze debba subire chi sceglie di farlo: «È possibile che per salvare una persona se ne possa torturare un’altra. La domanda è cosa succede dopo. Dopo devi essere punito perché hai torturato una persona».
L’escalation bellica e la militarizzazione della tortura
Anche riguardo alla tortura l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha segnato un drammatico punto di svolta, distruggendo quel poco che si stava facendo di positivo grazie alle denunce di giornalisti e difensori dei diritti umani.
La guerra ha introdotto due nuove dimensioni nella pratica della tortura: quella applicata ai prigionieri di guerra ucraini e quella utilizzata per costringere i detenuti russi ad arruolarsi nell’esercito. Per quanto riguarda i primi, i reduci raccontano di condizioni di detenzione che violano sistematicamente le convenzioni di Ginevra.
Ancora più inquietante è l’uso sistematico della tortura per il reclutamento forzato. Nell’estate 2022 è stata emanata una direttiva per assicurare un certo numero di detenuti disposti a firmare contratti militari e partire per la guerra. I prigionieri erano consapevoli del destino che li attendeva al fronte e si rifiutavano di arruolarsi volontariamente, perciò le autorità hanno fatto ricorso anche alla tortura (oltre alle promesse di facili guadagni e amnistie), per evitare che, per colmare le «quote» mancanti, venisse inviato al fronte il personale carcerario.
A ciò si è aggiunta la sistematica liquidazione delle organizzazioni per i diritti umani – osserva Sadovskaja, – altro elemento cruciale della strategia repressiva, dato che le organizzazioni pubbliche, in un modo o nell’altro legate alla lotta alla violenza, si sono trovate ad essere «non gradite», e il marchio di «agente straniero» o peggio ancora di «organizzazione estremista» colpisce indiscriminatamente «lo strato della società civile che difende qualcuno o qualcosa» e che viene percepito come una minaccia potenziale all’ordine costituito.
Nonostante lo scenario poco rassicurante, rimangono spazi di resistenza e documentazione. Il lavoro del Comitato contro la tortura continua, seppure in condizioni sempre più difficili.
Ciò che succede in Russia non rappresenta certo un’eccezione; se mai, la sua specificità sta nella routine amministrativa e nella capacità del regime di sottrarsi a ogni forma di controllo esterno, e il probabile ritiro dalla Convenzione europea rappresenta l’ultimo atto di questa strategia di autoassoluzione: eliminare non la tortura, ma la possibilità di documentarla e denunciarla efficacemente. Nel frattempo, intere generazioni cresceranno in un sistema che ha normalizzato la violenza istituzionale, che ha trasformato la tortura da aberrazione in strumento ordinario di governo.