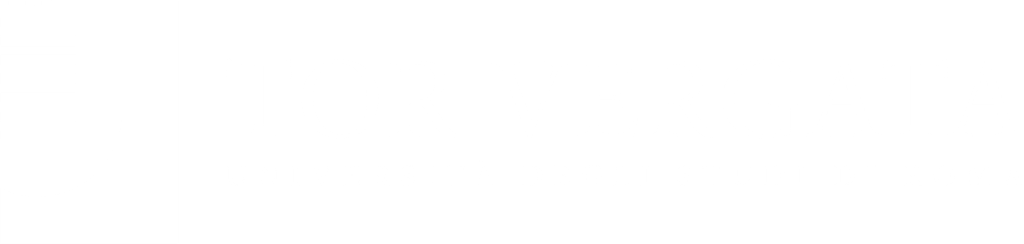Carolina De Stefano

Con la morte di Aleksej Naval’nyj l’opposizione politica interna in Russia è stata neutralizzata. In tale contesto, nei prossimi anni non si formeranno partiti politici antigovernativi, ed è più probabile che eventuali proteste future prendano la forma di rivendicazioni etno-nazionali nelle periferie. Già lo scorso mese, le manifestazioni più importanti da tempo non si sono svolte a Mosca, ma in Baškortostan, repubblica nella regione del Volga. I manifestanti hanno protestato contro la condanna a quattro anni di carcere di un nazionalista e attivista ecologista locale, Fail Alsymov, accusato di aver “inneggiato all’odio razziale” in un suo discorso. La sua incarcerazione rientra in una politica di repressione dei movimenti nazionalisti, e più recentemente di chiunque critichi apertamente la guerra. Queste proteste non rappresentano alcuna minaccia a Putin in vista delle elezioni presidenziali di marzo, ma sono rivelatrici di contraddizioni e problemi strutturali del regime russo che si sono acuiti dall’inizio della guerra e che dovranno essere affrontati in futuro.
Innanzitutto, per il Cremlino resta più difficile giustificare la repressione di figure che rivendicano un’autonomia culturale e linguistica locali che non manifestazioni apertamente antigovernative. I manifestanti non hanno protestato per la guerra in corso, ma a favore di un nazionalista che si presenta come difensore dell’identità baškira. La Russia è formalmente una repubblica federale multietnica. Anche se negli ultimi venticinque anni ha accentrato il potere nelle sue mani, Putin continua a fare riferimento alla diversità etno-culturale del paese come un valore fondamentale. Non si tratta solo di parole, ma anche di pragmatismo. Per come è organizzata, la Russia non può permettersi di essere dominata da un discorso ufficiale che celebra la superiorità dei russi e degli slavi sulle altre popolazioni. Il rischio, più acuto da quando il Cremlino ha rafforzato la sua retorica nazionalista e anche razzista, è che emerga uno scontento generalizzato da parte delle élite e della popolazione locali, soprattutto di repubbliche etniche con una tradizione di separatismi e conflitti del Caucaso del Nord, come il Daghestan o la Kabardino-Balkaria, o ricche di risorse naturali come la Jakuzia. In altri termini, la polizia può disperdere le proteste, ma il regime sarà costretto un giorno a fare nuove concessioni ai territori per evitare che le tensioni tra il centro e le repubbliche crescano.
Le manifestazioni mostrano anche perché è sbagliato parlare delle relazioni tra russi e non russi come di uno scontro tra due gruppi ben definiti. In molti, compreso Aslymov, hanno criticato la guerra sostenendo che le minoranze del paese, tra cui i baškiri, sarebbero state mobilitate in Ucraina più dei russi etnici, subendo quindi una discriminazione volontaria da parte del governo. Ma se il problema fosse puramente etnico, come si spiega il fatto che la popolazione ha manifestato contro il presidente della repubblica Radij Chabirov, colpevole di avere aperto il caso contro Aslymov, e che Chabirov è di etnia baškira ma anche un fedelissimo di Putin? In realtà, le discriminazioni sono innanzitutto economiche (i soldati provengono dalle regioni più povere, e spesso ma non sempre si tratta di repubbliche etniche) e il problema del Cremlino non sono i gruppi etnici in quanto tali, ma le élite che governano i territori. Fino a quando il presidente del paese ha il controllo dei leader locali, l’architettura federale regge. Le rivendicazioni su base etno-nazionale e le spinte centrifughe potrebbero emergere invece se il centro è più debole o le risorse da redistribuire diminuiscono.
Infine, il caso Aslymov rivela la schizofrenia del discorso ufficiale e delle politiche del Cremlino. In una Russia che dall’inizio della guerra ha dato uno spazio senza precedenti a nazionalisti e antisemiti a condizione che non criticassero la guerra, Aslymov non è stato condannato per le sue idee, ma per l’utilizzo di un’espressione (“qara halyq”, letteralmente “persone di colore”) considerata poco rispettosa dei migranti, come se la Russia fosse un baluardo della cultura woke. Il regime putiniano ricorda sempre di più quello staliniano ma, contrariamente a quest’ultimo, non si fonda su un’ideologia precisa, ma sull’improvvisazione.