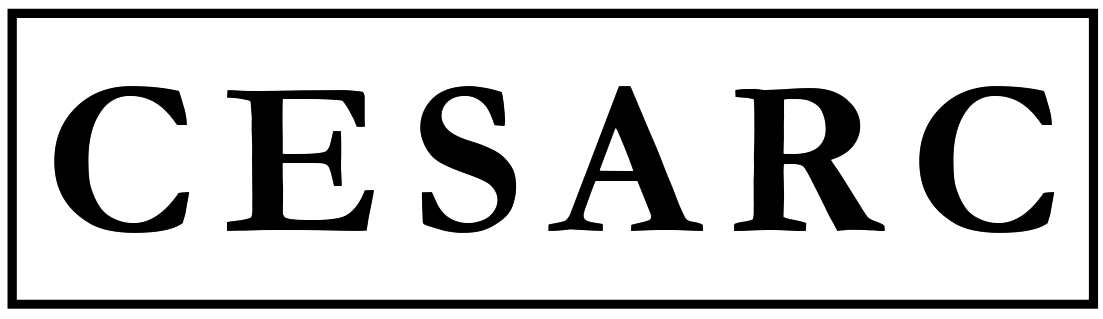Jean-Marie Reure
“Don’t do Russia policy without consulting people who know far more about Russia than you do. Don’t rely on people who have been trained as diplomats but have no real understanding of patterns of Russian behavior”.
T. Hendrik Ilves, ex Presidente dell’Estonia, in un ‘intervista rilasciata a Politico il 09/03/2022

Le parole di Toomas Hendrik Ilves lasciano trasparire la frustrazione degli stati membri dell’UE che confinano con la Russia per il modo in cui l’Occidente ha impostato le relazioni con Mosca a partire dal crollo dell’Unione Sovietica. Numerosi leader statunitensi ed europei, da Obama a Merkel, sono ora accusati di essere stati ingenui, se non addirittura deliberatamente miopi rispetto alle intenzioni russe (Lau 2022, Kuzio 2024). D’altronde, se l’annessione illegale della Crimea nel 2014 aveva definitivamente escluso la possibilità di un “reset” nei rapporti con la Federazione Russa (Rachwald 2011), le speranze di trovare un terreno comune con la leadership russa non si sono mai del tutto sopite. Infatti, nel 2021 un rapporto di Chatham House annoverava ancora fra i falsi miti più diffusi l’idea che Russia e Occidente in fondo volessero le stesse cose, che non fossero in conflitto, o che una nuova architettura di sicurezza europea avrebbe dovuto necessariamente includere la Russia (Allan et al. 2021). Persino dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022, alcuni analisti continuano a sostenere che la Russia rappresenti una minaccia limitata e che stia solo agendo in reazione alle politiche occidentali (Chau and Wang 2023).
Non si tratta in questo caso di capire che tipo di minaccia rappresenti la Russia, ma piuttosto di riflettere sul modo in cui pensiamo a questo e ad altri avversari. Infatti, in Occidente si tende spesso a privilegiare fattori materiali e misurabili (Hackett et al. 2022, Shultz and Brimelow 2022) come numero di truppe, armamenti e percentuali del PIL dedicate alla difesa, tralasciando il più ineffabile mondo delle idee, percezioni e quadri cognitivi (Renz 2024). Eppure illustri studiosi come Fuller (2008) o Gray (2014) hanno dimostrato l’importanza di questi elementi non solo nella comprensione ma anche nella progressiva evoluzione della strategia. A tal riguardo conviene però distinguere le velleità culturaliste di buona parte della produzione “geopolitica” italiana, che tenta di ricondurre acriticamente la prassi strategica a un fatto culturale-identitario (Recordati-Koen 2024), da quello che la Scienza Politica chiama cultura strategica. Quest’ultimo concetto si può definire come un “sistema di simboli [che] incarna i presupposti relativi alle problematiche della sicurezza e, di conseguenza, su come affrontarle al meglio” (Johnston 1998, p. 39). La sua utilità non risiede tanto nel mostrare una presupposta continuità con il passato, che porta inevitabilmente a trascurare gli elementi di cambiamento (Baudet 2013, Zelikow 2015), ma nel fare luce sulla dimensione non materiale che contraddistingue qualsiasi decisione politica.
Ed è precisamente questo terreno che Dimitri Minic calca in “Pensée et culture stratégiques Russe. Du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine” (Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection, 2023). Basandosi su oltre 260 autori pubblicati in riviste scientifico-militari russe di primo piano (tra cui Voennaia Mysl’, Voenno-promyshlennyi kur’er e Mezhdunarodnaia zhizn’), su svariati documenti dottrinali, discorsi pubblici e dizionari militari, Minic analizza più di 1.200 articoli scritti fra il 1999 e il 2021. Questa ricerca approfondita gli consente di ricostruire l’evoluzione del pensiero e della cultura strategica russa post-sovietica in modo più ampio e dettagliato rispetto alla maggior parte dei (pochi) studi esistenti (Kukkola 2023, McDermott and Bartles 2023, Göransson 2024).
È dunque alla luce del dibattito sulle intenzioni del Cremlino che si impone la domanda circa il contributo offerto dallo studio della letteratura e della cultura militare russa. Muovendo da tale interrogativo, l’analisi qui presentata si articola in tre momenti: dapprima si delineano i principali temi affrontati nel volume di Dimitri Minic; successivamente si valutano i punti di forza e i limiti dell’opera; infine, si amplia la riflessione alle implicazioni di un approccio che includa fattori materiali e non materiali nell’analisi delle decisioni di politica internazionale.
Pensiero e Cultura Strategica Russa: dall’elusione della lotta armata alla guerra in Ucraina
Il libro, edito dalla Maison des Sciences de l’Homme di Parigi, è uno studio denso e ambizioso che analizza l’evoluzione della concettualizzazione della guerra contemporanea nell’ambiente strategico russo. I primi due capitoli si concentrano sulla teorizzazione dell’“elusione (contournement) della lotta armata” e sulle dispute epistemologiche che caratterizzano la letteratura scientifico-militare russa. I capitoli III–V muovono dal dibattito teorico al quadro cognitivo più ampio (cioè le lenti interpretative) attraverso il quale gli strateghi russi interpretano la sicurezza e la difesa nazionale. Il capitolo finale interpreta poi la guerra di aggressione contro l’Ucraina attraverso la lente della cultura strategica russa.
L’introduzione chiarisce come lo scopo del volume sia quello di mostrare il processo di elaborazione del nuovo concetto di guerra adottato nella dottrina russa. L’inclusione di “mezzi non militari” costituisce infatti uno sviluppo originale del pensiero russo, soprattutto se messo a confronto con la pesante eredità sovietica che storicamente definisce la guerra quasi esclusivamente in termini di lotta armata. Sebbene numerosi studi abbiano analizzato le conseguenze strategiche ed operative di questo importante cambiamento dottrinale in diversi contesti (dall’Africa all’Ucraina), il dibattito scientifico ha essenzialmente inquadrato la questione utilizzando categorie concettuali occidentali, dando minor rilievo alla letteratura militare russa. Il libro vuole quindi colmare questa lacuna analizzando in modo sistematico non solo la letteratura russa ma anche il quadro cognitivo dei suoi strateghi della quale è espressione (p.28)
Il primo capitolo traccia l’evoluzione del dibattito circa “l’elusione della lotta armata” distinguendo tre periodi principali. Nel primo periodo (1993–2000), i concetti di lotta o guerra dell’informazione non compaiono neidizionari militari ufficiali. Si identificano infatti esclusivamente i concetti di lotta ideologica e guerra psicologica come forme di confronto non armate. Nel secondo periodo (2000–2010) avviene invece una polarizzazione del dibattito fra i proponenti di una militarizzazione del concetto di informazione e coloro che ritengono che la sola informazione possa raggiungere obiettivi strategico-politici senza l’impiego delle armi. L’esperienza delle rivoluzioni colorate (Mitchell 2012) e della Primavera araba imprime infine una svolta alla teorizzazione dei concetti di guerra e di violenza. In questa terza fase (2010-2016) si viene a concepire la guerra dell’informazione non più come un mezzo tecnico parte del più vasto repertorio militare, ma come un vero e proprio strumento volto a perseguire obiettivi di natura politica (al pari quindi dello strumento militare stesso). Da questa innovazione derivano alcune conseguenze teoriche rilevanti. Si sviluppa infatti la nozione di approccio (o strategia) indiretto, che riflette sia la progressiva estensione del campo di battaglia – con l’utilizzo di missili di precisione, droni, capacità di ingaggio stand-off ecc. (Knowles and Matisek 2019, McDonald 2021) – sia il progressivo ricorso a strategie che non implicano il massiccio dispiego di forze. Laddove l’asimmetria veniva esclusivamente pensata come uno strumento del forte contro il debole, ora diviene il mezzo attraverso il quale un attore compete con un avversario più forte evitando lo scontro armato. Contestualmente, il dibattito sulle forze speciali e irregolari conosce un’espansione significativa, e si individuano insorti, formazioni irregolari, compagnie militari e di sicurezza private, e ONG come potenziali strumenti per evitare il conflitto, sfruttando ambiguità, rendendo difficile l’attribuzione di atti ostilie logorando l’avversario in modo preventivo. Infine, la stessa nozione di deterrenza include ormai l’impiego – anche preventivo – di metodi non militari e indiretti al fine di scongiurare l’impiego della violenza.
Il secondo capitolo traccia l’evoluzione del dibattito sulla natura della guerra dal 1991 ad oggi, alla luce del confronto dialettico fra pensatori tradizionalisti e revisionisti. La pesante eredità sovietica non ha infatti impedito, a partire dagli anni Novanta, un vivace dibattito che rimetteva in questione la definizione di guerra come confronto armato allargandola ai concetti di coercizione e violenza non militari. Se inizialmente queste spinte revisioniste trovano la ferma opposizione dei tradizionalisti, nel corso degli anni Duemila si intensifica la riflessione che pone guerra e pace in un continuum. Le necessità di adattare la dottrina militare a un nuovo contesto strategico e di ridefinire un nuovo ruolo per le forze armate della Federazione Russa si riflettono inevitabilmente sulla discussione. Il 2013 rappresenta una giuntura critica (Capoccia and Kelemen 2007), non tanto per la pubblicazione della cosiddetta dottrina Gerasimov (Galeotti 2019), quanto per la progressiva inclusione dei temi revisionisti nei discorsi ufficiali e nei dizionari militari. Le conseguenze istituzionali di questa svolta sono evidenti: nascono il Dipartimento di Sicurezza Informatica presso l’Accademia di Stato Maggiore, il Comando delle Forze per le Operazioni Speciali, il Comando Informatico in seno allo Stato Maggiore e il Centro Nazionale della Gestione della Difesa. Queste riforme mirano infatti a costruire un sistema unificato di controllo dell’informazione statale e militare, consentendo alla Russia di adattarsi alle nuove forme emergenti di conflitto.
Il capitolo terzo analizza le influenze del pensiero strategico sovietico sul dibattito scientifico-militare contemporaneo. Secondo Minic, due elementi ne costituiscono l’ossatura: l’ideologia marxista-leninista e l’esperienza della Guerra fredda. L’interpretazione marxista-leninista di Clausewitz costituisce la conoscenza pregressa (Adler e Pouliot 2011) della maggior parte dei teorici militari russi. Fornisce un repertorio di idee e assunti sulla guerra cui revisionisti e tradizionalisti ricorrono indistintamente per legittimare una continuità dottrinale o per giustificarne la revisione. Il materialismo dialettico viene quindi interpretato da alcuni come una dottrina la cui inosservanza è responsabile dell’immobilismo intellettuale contemporaneo. Secondo altri si tratterebbe invece di un ostacolo fondamentale allo sviluppo di un pensiero militare moderno e scientifico che sia calato in un ambiente geostrategico in cui la Russia non può più guardare alla pari gli Stati Uniti. La Guerra fredda è invece l’esperienza centrale sulla quale si fonda il vivace dibattito scientifico-militare russo. I revisionisti, in particolare, vedono nella Guerra Fredda il prototipo delle guerre future e l’esemplificazione dell’elusione della lotta armata. È l’analisi di quest’esperienza che costituisce il materiale empirico per eccellenza sul quale si fonda l’elaborazione di concetti quali guerra senza confronto armato, stato permanente di guerra, approcci indiretti, violenza non armata e conflitto informazionale. Ed è proprio sulla base di quest’elaborazione collettiva dell’esperienza della Guerra Fredda che si creerà un consenso in seno alla leadership politica e militare russa sulla necessità di seguire una linea politica pragmatica, libera da dogmi e ideologia.
I capitoli quarto e quinto esplorano invece il quadro cognitivo dei teorici militari russi.Minic mostra come questo ambiente sia fortemente influenzato da un insieme di credenze spesso contraddittorie, che possono sfociare in vere e proprie teorie del complotto. È interessante notare come queste credenze non siano solo utilizzate in modo strumentale e a fini propagandistici, ma siano condivise da buona parte della leadership russa (Minic 2023, p. 222). Il quadro cognitivo dei teorici russi si articola quindi attorno a tre narrazioni dominanti (Coticchia and Catanzaro 2022): la percezione di un’ostilità diffusa nei confronti della Russia; la rappresentazione di un Occidente onnisciente, onnipresente e malevolo; e infine l’immagine di una Russia dal carattere eccezionale e dal destino unico. In quest’ottica, la Russia è immaginata come una potenza solitaria in stato di assedio permanente, minacciata non solo da potenze straniere ma anche da attori ineffabili quali la massoneria o una presunta oligarchia transnazionale intenzionata ad appropriarsi delle sue risorse naturali. L’Occidente è poi presentato come una minaccia esistenziale per la Russia. Si tratta di un’entità compatta e omogenea, guidata dagli Stati Uniti e mossa da intenti predatori. L’inganno, la violenza e la disinformazione sono gli strumenti principali attraverso cui questo Occidente persegue l’egemonia globale. Questa visione distorta e paranoica del mondo e degli avversari della Russia si basa su una reinterpretazione in senso teleologico e deterministico della storia, per cui persino eventi lontani fra loro vengono ricondotti a un disegno ordito ai danni della Russia. D’altro canto, la Russia non è solo rappresentata come forza di equilibrio nella politica mondiale, ma come attore fondamentalmente benevolo e pacifico. Grazie all’unicità della sua cultura e del suo destino, la Russia è raffigurata come il baluardo della resistenza all’imperialismo dell’Occidente e al degrado morale che questo porta. La riflessione sull’elusione della lotta armata può quindi essere interpretata come risposta alle percezioni di accerchiamento e di guerra permanente, ma anche come un adattamento necessario all’asimmetria dei rapporti fra la Russia e un Occidente potente quanto ostile.
Il capitolo sesto esplora il complesso rapporto della Russia con l’Occidente. Minic nota, infatti, come molti concetti originali del pensiero militare russo derivino in realtà da una lettura approssimativa e faziosa, sovente distorta, delle azioni occidentali e del pensiero di alcuni autori occidentali, fra cui figurano Brzezinski, Huntington, Mackinder, Spykman e Liddell Hart. Si tratta in realtà di una dinamica ricorrente: le idee innovative circa l’elusione della lotta armata vengono inizialmente (e spesso erroneamente) attribuite all’Occidente; sono poi rielaborate dai teorici russi, e infine adottate in risposta a una presunta ostilità occidentale. Tuttavia, molti di questi concetti “presi in prestito” all’Occidente restano vaghi, e sono alimentati da una sorta di pensiero magico – si noti ad esempio la convinzione di alcuni teorici russi circa l’esistenza di tecnologie in grado di “scannerizzare la mente collettiva umana” (Minic 2023, p. 300). Lo scarso rigore metodologico della scienza militare russa emerge in particolare dall’analisi di tre nozioni centrali nel discorso strategico russo: guerra dell’informazione, rivoluzioni colorate e caos controllato. Gli scritti russi sulla guerra dell’informazione e l’enfasi sulla sua dimensione psicologica derivano infatti da una lettura distorta della dottrina statunitense (che si concentra essenzialmente su mezzi elettronici e cyber) e da un’interpretazione della Guerra fredda come conflitto dell’informazione pilotato (e vinto) dagli USA. Allo stesso modo, le rivoluzioni colorate vengono interpretate come frutto di un disegno occidentale volto a destabilizzare stati e promuovere cambi di regime contrari agli interessi di Mosca attraverso i mezzi della “promozione della democrazia”. Le proteste in Ucraina, Georgia, Libia, Egitto, Tunisia e Yemen sono poi collegate alla cosiddetta strategia del caos controllato, erroneamente attribuita a Steven R. Mann (1992), secondo cui l’Occidente mirerebbe a provocare trasformazioni socio-politiche alimentando deliberatamente disordine e instabilità.
Infine, il capitolo settimo analizza la guerra di aggressione contro l’Ucraina alla luce della tradizione teorico-militare russa. L’“operazione militare speciale” lanciata nel febbraio 2022 al tempo stesso conferma e contraddice quanto teorizzato circa l’elusione della lotta armata. Da un lato, infatti, il periodo 2014-2021, con l’annessione russa della Crimea e di parte del Donbass, sembra confermare la rilevanza di questa nuova concezione di guerra. Dall’altro però, l’invasione su larga scala dell’Ucraina e il passaggio nel 2022 a una guerra d’attrito che ha prodotto guadagni territoriali limitati a fronte di costi umani e materiali enormi, mettono in luce i limiti intrinseci di questo approccio indiretto. Secondo Minic, la fiducia eccessiva nell’efficacia dei metodi ibridi e non militari ha alimentato l’illusione strategica che un’operazione rapida potesse bastare a conseguire obiettivi politici, portando Mosca a sottovalutare la resilienza ucraina e il ruolo del sostegno occidentale. In questo senso, Minic propone una spiegazione culturale e ideazionale della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze: la cultura strategica russa, impregnata di un senso di accerchiamento e conflitto perenne, ha predisposto la leadership Russa all’aggressione distorcendone la percezione di sé e degli altri, di fatto gettando le basi per un grave errore strategico come quello commesso a febbraio del 2022.
Analisi
Uno dei principali punti di forza del volume risiede proprio nella sua ampia analisi empirica. Minic non si limita ad analizzare in modo approfondito la letteratura scientifico-militare russa, ma si concentra specificamente su articoli scritti in russo e destinati a un pubblico interno. Questo gli consente di mappare in modo dettagliato il dibattito teorico russo, evitando fonti tradotte in inglese e quindi potenzialmente destinate a un pubblico “esterno”. Risulta poi particolarmente convincente il processo (implicito) attraverso il quale Minic valida le proprie conclusioni. Se si intende la cultura strategica come una realtà negoziata tra élite (Berger 1998), allora il confronto tra i dibattiti propri della letteratura scientifico-militare da un lato e le nozioni impiegate nei dizionari militari ufficiali, nei testi di dottrina e nelle dichiarazioni ufficiali dall’altro risulta un metodo efficace per cogliere l’interazione dinamica fra le idee, la loro istituzionalizzazione dottrinale e le prassi che ne discendono. Ovviamente questo processo di validazione delle osservazioni si regge sul presupposto che documenti e dichiarazioni ufficiali individuino degli interessi fondamentali e dettaglino i mezzi identificati per raggiungerli (Choi 1996). Altresì notevoli sono le appendici del libro, che non solo attestano la meticolosità della ricerca di Minic, ma forniscono anche informazioni essenziali sugli stessi teorici militari, incluse anzianità, esperienze e grado. Pur non tracciando direttamente le traiettorie dei singoli teorici militari, queste informazioni aggiuntive permettono di “profilare” gli autori che hanno contribuito al dibattito strategico russo in relazione alle esperienze da loro vissute.
Grazie al rilevante sforzo di analisi e di traduzione della letteratura scientifico-militare, il volume si configura quindi come una fonte autorevole per lo studio della cultura strategica russa. Al tempo stesso, il suo contributo travalica i confini dell’analisi d’area, alimentando più ampi dibattiti sul ruolo della leadership, dell’innovazione e della strategia nella condotta della guerra. Si notino al riguardo due punti in particolare.
In primo luogo, sebbene le tecnologie moderne di sorveglianza e informazione abbiano reso il campo di battaglia più “trasparente” che mai, la nebbia della guerra non è stata eliminata. Una maggiore visibilità non si traduce automaticamente in maggior chiarezza cognitiva (cioè la capacità di interpretare le intenzioni, anticipare inganni e depistaggi e comprendere la logica strategica dell’avversario). Al contrario, l’abbondanza di dati e informazioni può instillare un senso di fiducia eccessivo creando un’illusione di onniscienza (Kunertova and Herzog 2024, Néron-Bancel and Garnier 2024). È proprio in un contesto di sovrabbondanza informativa che il lavoro di Minic offre uno strumento concettuale prezioso per comprendere come i teorici militari russi inquadrano la guerra, integrando all’analisi dei fattori materiali anche elementi non materiali. Si pensi, ad esempio, alla questione molto dibattuta del costo della guerra. Per chi si chiedesse quali costi la Russia sia disposta a sostenere sul campo, il semplice conteggio dei mezzi distrutti, della quota di PIL destinata alla difesa o del tasso di rigenerazione delle perdite fornirebbe solo una risposta parziale. Solo considerando il ruolo dei fattori non materiali, come la concezione della guerra e dei suoi scopi condivisa dalle élite russe, è possibile offrire un quadro più completo e approfondito che permetta a un analista di abbozzare una risposta a una domanda così complessa.
In secondo luogo, occorre ricordare che la Russia è uno stato autoritario, e per studiosi e analisti interessati alle questioni di difesa il paese non è accessibile. Dati affidabili sono quindi estremamente difficili da ottenere, ma questa non dovrebbe essere una ragione ostativa per formulare domande che mirino ad indagare aspetti che richiedono una conoscenza approfondita del contesto russo. Minic dimostra infatti che è possibile fare ricerche rigorose sulla Russia, evitando di ricorrere a strumenti metodologici che presuppongano la presenza fisica sul campo (Janenova 2019). Inoltre, questo studio sull’elusione della lotta armata getta le basi per più ampi studi che, anche in ottica comparata, analizzino le questioni dell’innovazione e del cambiamento in seno alle forze armate russe. Recenti studi sulle trasformazioni militari in Italia, Giappone, Germania e Francia non solo si sono rivelati promettenti, ma hanno anche dato un nuovo impulso allo studio della cultura strategica come uno dei fattori all’origine delle più recenti trasformazioni istituzionali (Dian et al. 2023, Schmitt 2024).
Pur costituendo una fonte preziosa per studiosi e analisti, la struttura del volume risulta leggermente confusionaria, e i lettori rischiano di sentirsi sopraffatti dalla mole di informazioni e riferimenti contenuti in ciascun capitolo. Benché il libro raggiunga pienamente l’obiettivo di mostrare la progressiva ridefinizione del concetto di guerra avvenuta nell’ambiente strategico russo, sorprende la scelta di iniziare dal dibattito tecnico-dottrinale (cap. I e II) per poi allargare la discussione ad aspetti più generali quali cultura (cap. III) e quadri cognitivi dei teorici stessi (cap. IV, V e VI). Una struttura invertita, che muovesse innanzitutto dagli elementi più ampi (la cultura sovietica e l’universo cognitivo dei teorici russi) per arrivare gradualmente a questioni più circoscritte come l’evoluzione dottrinale e il suo impatto sulla guerra, avrebbe probabilmente garantito una maggiore efficacia analitica, senza per questo risultare eccessivamente descrittiva.
Un secondo limite riguarda la scarsità di riferimenti alla più ampia letteratura sulla cultura strategica. Sebbene l’introduzione e il capitolo sesto facciano riferimento ad alcune opere importanti, la tesi di Minic avrebbe potuto essere inquadrata nel contesto della più recente letteratura di Relazioni Internazionali (Lantis 2009, Götz and Staun 2022, Kartchner et al. 2023, Snyder 2023). Infatti, lo studio della cultura strategica si è progressivamente affinato, acquisendo maggior rigore metodologico. L’omissione di questa “nuova generazione” di studi non riduce il valore empirico del libro ma ne limita la portata teorica, lasciando inesplorato il contributo che il caso russo può offrire al più ampio dibattito sul ruolo delle idee e delle visioni del mondo nella sicurezza internazionale. Allo stesso modo, l’autore affronta una questione interessante e complessa come quella del ricorso da parte dei teorici militari russi a vere e proprie teorie del complotto con pochi riferimenti a una pur vivace letteratura che si è interessata a queste tematiche (Girard 2008, Douglas et al. 2019, Douglas and Sutton 2023, Hornsey et al. 2023). Rimane altresì inesplorato il rapporto fra la diffusione di idee complottiste in seno alla leadership strategica russa, e l’utilizzo ricorrente delle medesime teorie nell’ambito di campagne informative rivolte ad un pubblico esterno alla Federazione (US State Department 2020, Audinet 2021, Laruelle and Limonier 2021, Audinet and Dreyfus 2022).
Il libro inoltre non affronta due aspetti che avrebbero potuto rafforzare l’impatto della ricerca: Il confronto con la dimensione operativa e lo stato delle relazioni civili-militari in Russia. Per quanto concerne il primo punto, il libro si concentra volutamente su pensiero e cultura strategica, eppure un cenno alla relazione fra teoria e pratica avrebbe forse permesso di chiarire anche il contorno di alcuni dibattiti teorici. Non è infatti chiaro in che misura concetti come quelli del “controllo riflessivo”; della “lotta informativa” o “lotta psicologica” si traducano nella pratica militare russa. Sebbene l’ultimo capitolo (sulla guerra in Ucraina) unisca in un certo senso la dimensione teorica a quella pratica, il significato operativo di questi termini è sostanzialmente lasciato all’interpretazione del lettore. Infine, la mancata attenzione allo stato delle relazioni civili-militari in Russia, lascia in ombra una dimensione cruciale della cultura strategica: il suo carattere negoziale, prodotto delle interazioni fra élite, istituzioni e società (Kohn 1997, Feaver 2017, Brooks 2019, Pion-Berlin and Dudley 2020). Valutare se e in che modo le élite militari traggano legittimità dall’opinione pubblica, o se al contrario impongano le proprie narrazioni a quest’ultima, permetterebbe di valutare meglio la resilienza della cultura strategica russa. Inoltre un riferimento allo stato delle relazioni civili-militari in Russia consentirebbe di collegare più direttamente il volume con la ricerca comparata che indaga la formazione, la trasmissione e la trasformazione delle culture strategiche (Johnston 1998, Derinova 2013, Dagi 2024).
Discussione: oltre la cultura strategica russa, il bisogno di competenza per comprendere la politica mondiale
Uno dei principali insegnamenti che si possono trarre dal volume riguarda l’importanza di fattori ideazionali e non materiali nell’analisi del comportamento strategico di un attore. Sebbene questo tipo di studi non possa da solo aspirare a spiegare scelte politiche e militari, costituisce un complemento ideale alle spiegazioni razionaliste. Infatti, ricostruire l’ambiente cognitivo nel quale opera un attore aiuta a comprenderne la razionalità (Swidler 1986, March and Olsen 2006, Hopf 2010, Schulz 2016), facendo chiarezza sulle logiche d’azione che lo guidano. Questo elemento è cruciale sia per raffinare la ricerca accademica sia per guidare la decisione politica, offrendo un contesto interpretativo “denso”. Infatti, laddove la ricerca mira lato sensu a spiegare determinati fenomeni, il decisore politico non si limita ad osservare, ma ambisce a trarne lezioni che si traducono a loro volta in scelte concrete.
A tal proposito, Fuller (2008) ricorda che ogni “lezione appresa” contiene due elementi: una riflessione su quanto avvenuto e una “profezia” sulle sue conseguenze future. Entrambi gli aspetti presentano delle significative difficoltà dal punto di vista teorico e pratico. Le riflessioni sono sempre soggettive, e la profezia è già implicita nell’interpretazione. Come scrive Fuller, “l’interpretazione [di un evento] senza una profezia equivarrebbe a un mero esercizio di ricostruzione storica dei fatti che non contribuirebbe in alcun modo alla teoria militare. Nella maggior parte delle lezioni apprese, la profezia è talmente radicata nell’interpretazione da esserne parte integrante (ibid. 2008, p. 45)
Sulla base di queste considerazioni, la ricerca ha indagato i modi in cui i decisori politici orientano le proprie scelte. Zelikow (2015) scompone il processo decisionale in giudizi di valore (ciò che è rilevante), giudizi di realtà (ciò che sta accadendo) e giudizi d’azione (cosa posso fare), in costante interazione fra loro. Nel formulare dei giudizi di realtà (rispondere cioè alla domanda “cosa sta accadendo?”) i decisori politici ricorrono spesso al passato per mezzo dell’analogia, paragonando quindi situazioni presenti o potenziali scenari futuri a precedenti storici (Khong 2022). Questo ragionamento non è dissimile da quello controfattuale, che Lebow (2000, p. 551) definisce come proposizioni condizionali (what if, e se…) circa eventi passati, in cui si modificano variabili, contesti e fattori per valutare l’impatto di queste differenze[1]. A differenza del ragionamento controfattuale, quello per analogia può essere sempre considerato come una proposizione condizionale che lega però passato e futuro: e se la scelta odierna equivalesse a una scelta che è stata fatta in passato, con queste conseguenze che sono già state osservate? In entrambi i casi, come osserva Fearon (1991), si tratta di un ragionamento di tipo causale. Applicando questa prospettiva al ragionamento di Zelikow, appare evidente come giudizi di realtà ed azione siano fra loro strettamente correlati: trarre lezioni dal passato equivale a identificare meccanismi causali che potenzialmente potrebbero operare anche in futuro. Il processo di apprendimento che scaturisce dall’osservazione di determinati fatti sociali è dunque eminentemente soggettivo. Questo non lo rende però meno importante, poiché è proprio l’apprendimento dall’esperienza che consente adattamento e innovazione. In conseguenza, l’unico rimedio contro potenziali errore di giudizio derivanti dall’assoluta arbitrarietà dell’apprendimento dall’esperienza risiede nell’educazione e nella conoscenza di chi osserva (Collins et al. 2004, King and Zeng 2007, Levy 2015, Mahnken 2020).
Da ciò conseguono due importanti implicazioni. Per quanto concerne i decisori politici, occorre ricordare che se la competenza non può sostituire il giudizio politico, questa rimane comunque una condizione indispensabile per esercitare l’attività decisionale. Purtroppo però un crescente numero di fonti accademiche (Vagle and Brooks 2025) e giornalistiche (Mackinnon 2025, Roth 2025, Strobel et al. 2025) segnala una mancanza di expertise diffusa fra i più alti vertici politici, un fenomeno che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate e pericolose. Per quanto concerne invece il più ampio pubblico di lettori interessati alle relazioni internazionali, l’intrinseca soggettività del processo di apprendimento dall’esperienza (propria e altrui), dovrebbe alimentare un salutare scetticismo nei confronti di narrazioni mistiche della guerra e di altri avvenimenti internazionali, veicolati dal genere sempre più diffuso del commento “geopolitico”. Questi resoconti tendono infatti a presentare la strategia come una realtà tangibile, razionalizzando retrospettivamente gli eventi in modo non dissimile da quello che in psicologia viene chiamato pareidolia (Recordati-Koen 2024). Sebbene questi racconti si rivestano di un’apparente chiarezza quasi intuitiva, non possono dunque costituire una base solida da cui trarre insegnamenti.
In conclusione, il libro di Minic dimostra che è possibile condurre degli studi rigorosi sulla strategia e sulla cultura strategica senza per questo scadere nel determinismo culturale o geografico. Questo tipo di sforzi intellettuali non arricchisce solo il dibattito accademico, ma costituisce anche una fonte di conoscenza rilevante per i decisori politici.
Riferimenti
Allan, D., Bohr, A., Boulègue, M., Giles, K., Gould-Davies, N., Hanson, P., Lough, J., Lutsevych, O., Mallinson, K., Marin, A., Nixey, J., Noble, B., Petrov, N., Schulmann, E., Sherr, J., Wolczuk, K., and Wood, A., 2021. Myths and misconceptions in the debate on Russia : How they affect Western policy, and what can be done. Chatham House.
Audinet, M., 2021. Le Lion, l’Ours et les Hyènes: Acteurs, pratiques et récits de l’influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone. Étude de l’IRSEM, 83, 69–85.
Audinet, M. and Dreyfus, E., 2022. La Russie au Mali, une présence bicéphale. Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM).
Baudet, F., 2013. Some thoughts on the utilization of the past in the military. Air & Space Power Journal-Africa and Francophonie, 4 (4), 4–15.
Berger, T.U., 1998. Cultures of antimilitarism. Johns Hopkins University Press.
Brooks, R.A., 2019. Integrating the civil–military relations subfield. Annual Review of Political Science, 22, 379–398.
Capoccia, G. and Kelemen, R.D., 2007. The study of critical junctures: Theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism. World politics, 59 (3), 341–369.
Chau, J. and Wang, A., 2023. “I’ve been attacked… not with facts and logic, but personally”: John Mearsheimer on the War in Ukraine. Oxford Political Review.
Choi, K., 1996. An Approach to a Common Form of Defense White Paper. Korean Journal of Defense Analysis, 8 (1), 205–229.
Collins, J., Hall, N., and Paul, L.A., 2004. Counterfactuals and causation: History, problems, and prospects. MIT University Press.
Coticchia, F. and Catanzaro, A., 2022. The fog of words: Assessing the problematic relationship between strategic narratives, (master) frames and ideology. Media, War & Conflict, 15 (4), 427–449.
Dagi, D., 2024. Strategic culture and its (re)construction: What role for narratives and othering? Comparative Strategy, 43 (5), 576–590.
Derinova, A., 2013. The Role of Social Institutions in Shaping Strategic Culture. E-International Relations.
Dian, M., Moro, F.N., and Coticchia, F., 2023. Reluctant Remilitarisation. Transforming the Armed Forces in Germany, Italy and Japan After the Cold War. Edinburgh University Press.
Douglas, K.M. and Sutton, R.M., 2023. What Are Conspiracy Theories? A Definitional Approach to Their Correlates, Consequences, and Communication. Annual Review of Psychology, 74 (1), 271–298.
Douglas, K.M., Uscinski, J.E., Sutton, R.M., Cichocka, A., Nefes, T., Ang, C.S., and Deravi, F., 2019. Understanding Conspiracy Theories. Political Psychology, 40 (S1), 3–35.
Fearon, J.D., 1991. Counterfactuals and hypothesis testing in political science. World politics, 43 (2), 169–195.
Feaver, P., 2017. Civil–military relations and policy: a sampling of a new wave of scholarship. Journal of Strategic Studies, 40 (1–2), 325–342.
Fuller, W.C., 2008. What is a military lesson? In: Strategic Studies. Routledge, 44–60.
Galeotti, M., 2019. The mythical ‘Gerasimov Doctrine’ and the language of threat. Critical Studies on Security, 7 (2), 157–161.
Girard, P., 2008. Conspiracies and visions of conspiracies in France and Italy after the Second World War. European Review of History: Revue européenne d’histoire, 15 (6), 749–765.
Göransson, M.B., 2024. Russia’s thinking on new wars and its full-scale invasion of Ukraine. Defence Studies, 24 (3), 449–471.
Götz, E. and Staun, J., 2022. Why Russia attacked Ukraine: Strategic culture and radicalized narratives. Contemporary Security Policy, 43 (3), 482–497.
Gray, C.S., 2014. Strategy and defence planning: meeting the challenge of uncertainty. Oxford University Press, USA.
Hackett, J., Childes, N., and Barrie, D., 2022. If New Looks could kill: Russia’s military capability in 2022. IISS.
Hopf, T., 2010. The logic of habit in International Relations. European Journal of International Relations, 16 (4), 539–561.
Hornsey, M.J., Bierwiaczonek, K., Sassenberg, K., and Douglas, K.M., 2023. Individual, intergroup and nation-level influences on belief in conspiracy theories. Nature Reviews Psychology, 2 (2), 85–97.
Janenova, S., 2019. The Boundaries of Research in an Authoritarian State. International Journal of Qualitative Methods, 18, 1609406919876469.
Johnston, A.I., 1998. Cultural realism: Strategic culture and grand strategy in Chinese history. Princeton University Press.
Kartchner, K.M., Bowen, B.D., and Johnson, J.L., 2023. Routledge handbook of strategic culture. Taylor & Francis.
Khong, Y.F., 2022. How not to learn from history. International Affairs, 98 (5), 1737–1762.
King, G. and Zeng, L., 2007. When can history be our guide? The pitfalls of counterfactual inference. International Studies Quarterly, 51 (1), 183–210.
Knowles, E. and Matisek, J., 2019. Western security force assistance in weak states: Time for a peacebuilding approach. The RUSI Journal, 164 (3), 10–21.
Kohn, R.H., 1997. How Democracies Control the Military. Journal of Democracy, 8 (4), 140–153.
Kukkola, J., 2023. The rise and fall of the Russian strategy of indirect actions in Ukraine. National Defence University Working Pap.
Kunertova, D. and Herzog, S., 2024. Emerging and Disruptive Technologies Transform, but Do Not Lift, the Fog of War–Evidence from Russia’s War on Ukraine. Russia’s War Against Ukraine–Complexity of Contemporary Clausewitzian War, 2024, 146–161.
Kuzio, T., 2024. Nine Things Western Analysts Got Wrong About Russia and Its Invasion of Ukraine. The Jamestown Foundation, No. Volume: 21 Issue: 33.
Lantis, J.S., 2009. Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism. In: J.L. Johnson, K.M. Kartchner, and J.A. Larsen, eds. Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction. New York: Palgrave Macmillan US, 33–52.
Laruelle, M. and Limonier, K., 2021. Beyond “hybrid warfare”: a digital exploration of Russia’s entrepreneurs of influence.
Lau, S., 2022. ‘We told you so!’ How the West didn’t listen to the countries that know Russia best. Politico, 9 Mar.
Lebow, R.N., 2000. What’s so different about a counterfactual? World politics, 52 (4), 550–585.
Levy, J.S., 2015. Counterfactuals, Causal Inference, and Historical Analysis. Security Studies, 24 (3), 378–402.
Mackinnon, A., 2025. No experts in the room: Donald Trump to meet Vladimir Putin after loss of Russia specialists. Financial Times, 13 Aug.
Mahnken, T.G., 2020. Learning the lessons of modern war. Stanford University Press.
March, J.G. and Olsen, J.P., 2006. Elaborating the “new institutionalism”. The Oxford handbook of political institutions, 5, 3–20.
McDermott, R.N. and Bartles, L.C.C.K., 2023. An Assessment of the Initial Period of War: Russia-Ukraine 2022, Part Two. FMSO Foreign Perspectives Briefs.
McDonald, J., 2021. Remote warfare and the legitimacy of military capabilities. Defence Studies, 21 (4), 528–544.
Minic, D., 2023. Pensée et culture stratégiques russes: Du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine. Paris: Maison des Sciences de l’Homme.
Mitchell, L.A., 2012. The Color Revolutions. University of Pennsylvania Press.
Néron-Bancel, P. and Garnier, G., 2024. “At the Other Side of the Hill”: The Benefits and False Promises of Battlefield Transparency | Ifri. IFRI, No. 118.
Pion-Berlin, D. and Dudley, D., 2020. Civil-military relations: What is the state of the field. Handbook of military sciences, 1–22.
Rachwald, A.R., 2011. A ‘reset’ of NATO–Russia relations: real or imaginary? European Security, 20 (1), 117–126.
Recordati-Koen, M., 2024. Il miraggio della strategia nel discorso geopolitico italiano: una critica epistemologica. Quaderni di scienza politica, (1), 51–78.
Renz, B., 2024. Western Estimates of Russian Military Capabilities and the Invasion of Ukraine. Problems of Post-Communism, 71 (3), 219–231.
Roth, A., 2025. Trump alone in a room with Putin is a recipe for disaster – just look to their last meeting. The Guardian, 13 Aug.
Schmitt, O., 2024. Préparer la guerre: Stratégie, innovation et puissance militaire à l’époque contemporaine : Schmitt, Olivier: Amazon.it: Libri. PUF.
Schulz, M., 2016. Logic of Consequences and Logic of Appropriateness. In: M. Augier and D.J. Teece, eds. The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management. London: Palgrave Macmillan UK, 1–8.
Shultz, R.H. and Brimelow, B., 2022. Russia’s Potemkin Army. Modern War Institute.
Snyder, J.L., 2023. The Concept of Strategic Culture. In: Strategic Culture (s) in Latin America. Routledge, 19–28.
Strobel, W.P., Nakashima, E., Miller, G., and DeYoung, K., 2025. Trump, Gabbard fired top CIA Russia expert days after Alaska summit. The Washington Post, 27 Aug.
Swidler, A., 1986. Culture in action: Symbols and strategies. American sociological review, 273–286.
US State Department, 2020. Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem. Global Engagement Center (GEC).
Vagle, B.A. and Brooks, S.G., 2025. Command of Commerce: America’s Enduring Economic Power Advantage over China. Oxford, New York: Oxford University Press.
Zelikow, P., 2015. The Nature of History’s Lessons’. The Power of the Past: History and Statecraft, 281–309.
[1] Per maggiore chiarezza, un esempio di ragionamento controfattuale potrebbe essere chiedersi se la Germania nazista non avesse adottato la strategia della guerra lampo, quale sarebbe stata la conseguenza per l’Europa e le potenza alleate. Non si tratta in questo senso di un esercizio retorico fine a sé stesso, ma di un procedimento euristico volto a sottolineare il ruolo della guerra lampo in un determinato contesto.