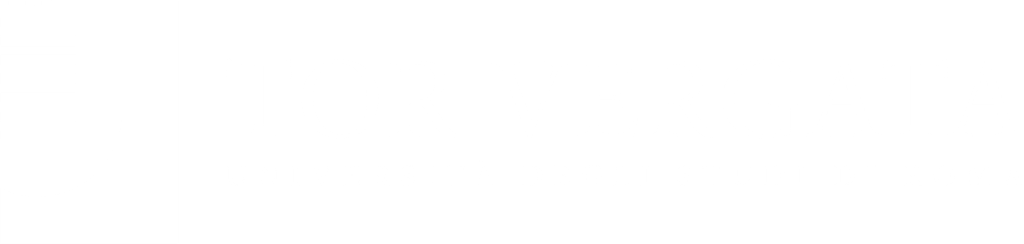Alberto Masoero
(Pubblicato originariamente sulla Rivista Storica Italiana, vol. CXXXIV, III, 2022. Si ringrazia la Direzione della Rivista Storica Italiana per la concessione)

1. Una sorpresa annunciata.
La sorpresa degli interpreti sembra ripetersi. Come accadde nel processo storico che portò alla fine dell’Unione sovietica, già allora con insospettata velocità, la brutale accelerazione della riconquista putiniana dello spazio post–sovietico e la determinazione della resistenza ucraina, con tutte le loro implicazioni e ramificazioni ben più vaste, sono apparse alla stragrande maggioranza degli specialisti come qualcosa di imprevisto e inatteso. In un modo o nell’altro hanno preso alla sprovvista chi doveva comprendere il reale con gli strumenti, vari e differenziati, del sapere.
In verità il senso di spiazzamento appare evidente anche nel commento delle principali ‘teste pensanti’ dell’establishment accademico russo in materia di relazioni internazionali. Ancora il 19 gennaio del 2022 Sergej Karaganov, che solitamente interpreta il ruolo del ‘falco’ influenzato dalla geoideologia totalitaria dell’eurasismo, commentava la crisi kazaca di inizio anno per segnalare l’incapacità delle repubbliche post–sovietiche di diventare «stati efficienti [deesposobnye]» e quindi dotati di autonoma sovranità. Prefigurava l’accelerazione di una moderna «raccolta delle terre» russe – la metafora storica dell’espansionismo del principato moscovita, formulata non a caso come conquista di ciò che è ritenuto proprio in partenza – e disegnava una traiettoria che dava per scontata non solo in Kazachstan o in Ucraina, ma anche in Bielorussia o in Armenia. E tuttavia Karaganov affermava perentoriamente che «non abbiamo assolutamente bisogno di combattere per l’Ucraina», «sono convinto che la conquista dell’Ucraina non rientri nei nostri progetti militari» giacché «occupare un paese […] con l’infrastruttura distrutta e una popolazione incattivita rappresenterebbe lo scenario peggiore»[1]. Uno sgomento palpabile traspariva dal primo commento alla guerra di Fëdor Luk’janov, direttore della rivista che ambisce a rappresentare il corrispettivo russo della statunitense «Foreign Affairs», pur nell’assenza di accenni critici. Notava con preoccupazione evidente che «Mosca ha fatto una scommessa enorme», un azzardo da cui avrebbe potuto uscire con successo solo «se la crisi attuale diventerà davvero la fine dell’ordine mondiale preesistente». Esprimeva le sue perplessità tra le righe citando le Lettere filosofiche (1836) di Pëtr Čaadaev e l’immagine di una Russia perennemente fuori dalla storia, una delle nazioni che «esistono solo per impartire al mondo una qualche importante lezione», anche se non è del tutto chiaro quale insegnamento abbiano impartito all’umanità le truppe che hanno fatto razzia di elettrodomestici a Irpin’[2].
L’incarico di spiegare la natura della guerra non è ricaduto sugli esperti russi di politica internazionale, a cui la divisione dei compiti nella politica del regime affida il ruolo di persuadere l’opinione pubblica accademica, più che di contribuire ad elaborare le decisioni politiche. Non è un caso che le dichiarazioni programmatiche siano venute, oltre che dai discorsi di Vladimir Putin, da figure di caratura intellettuale assai modesta, personaggi provenienti dal mondo delle pubbliche relazioni e del giornalismo, dei ‘tecnologi politici’ e del sottobosco ideologico della destra russa. Hanno assunto la forma della profezia apocalittica di Pëtr Akopov (la guerra come «nascita di un nuovo mondo») o di una descrizione dettagliata, cruda e spietata del programma di ‘denazificazione’ illustrato da Timofej Sergejcev: non una generica occupazione militare, ma un progetto di destrutturazione e trasformazione forzosa delle gerarchie economiche, sociali, istituzionali e mentali del territorio da conquistare, una guerra scatenata per «riformattare» le menti. Sono testi che dovrebbe leggere con attenzione chiunque cerchi di comprendere il conflitto in corso, partendo dalle fonti e dalle autorappresentazioni dei protagonisti, prima di sovrapporre agli eventi un quadro analitico[3].
Eppure la sorpresa dell’invasione ucraina era nascosta in bella vista. Le coordinate mentali che sottendono lo scontro risalgono come minimo al periodo del secondo mandato presidenziale di Vladimir Putin, tra il 2004 e il 2008. È facile rintracciarne le origini nelle modalità in cui settori della classe dirigente russa individuarono una propria via d’uscita dalla crisi degli anni novanta. In estrema sintesi: 1) un potere monocratico fondato sull’immedesimazione tra carica e persona, sancito dalla ‘staffetta’ Putin-Medvedev, con le relative implicazioni per la governance istituzionale; 2) la progressiva assunzione dell’obiettivo di una riunificazione in forme nuove dello spazio post-sovietico come criterio ideologicamente e persino religiosamente sentito del successo o fallimento della ‘nazione russa’, con la relativa delegittimazione degli stati nati da quella dissoluzione (non certo solo l’Ucraina); 3) la rivendicazione del ruolo di una ‘superpotenza etica’, anch’essa percepita come fine esistenziale: non solo uno stato militarmente potente, ma altresì portatore di un principio generale, una idea alternativa (di qualche genere) nella politica mondiale, atteggiamento che sottende già il discorso putiniano di Monaco del 2007[4]. Per restare al tema della politica energetica, come esempio particolare di indirizzi che maturavano da molto tempo, basterebbe ricordare la tesi di dottorato di Putin (1998, le risorse naturali come leva decisiva per la politica dello stato) o il pamphlet del 2005 in cui si profetizzava una «guerra economica» con l’Occidente, scritto da Dmitrij Rogozin, personaggio proveniente dall’estrema destra russa (il partito Patria) poi diventato uno dei massimi dirigenti del complesso militare-industriale[5]. In tutti questi aspetti è osservabile la tensione tra una retorica legittimante ispirata dalla ricerca della ‘stabilità’ (interna, post-sovietica, globale) e le conseguenze distruttive, in verità al massimo grado destabilizzanti, oggi sotto gli occhi di tutti. Bisognava essere ciechi per non vedere.
Avrebbe poco senso criticare gli storici per non aver previsto il futuro, ma può essere utile compiere un esercizio intellettuale opposto, chiedersi cioè in che modo la guerra in corso, di cui non conosciamo l’esito, ci induce a ridiscutere alcuni approcci storiografici più consueti e a problematizzarne gli assunti. Come ha notato l’editoriale di «Ab Imperio», una delle riviste più vivaci nate dal rinnovamento storiografico russo degli anni novanta, la cui redazione è ora in esilio, «there must have been some deficiencies in global Russian studies if the politics of history promoted by Putin’s regime and discussed as a legitimate theory was not outright discarded as outlandish when it began taking shape at the turn of this century»[6]. Marco Puleri e Vanessa Voisin hanno impostato bene il problema rilevando che «abbiamo inconsciamente utilizzato gli stessi strumenti offerti dalla retorica politica russa» e, questo il punto fondamentale, «lo abbiamo fatto senza però conoscere», o almeno senza comprendere con sufficiente chiarezza, «il processo di formazione di questa visione geopolitica e la storia recente della costruzione di questo immaginario ad uso e consumo, in primo luogo, del dibattito interno alla Federazione Russa e, solo in seconda battuta, dell’opinione pubblica internazionale»[7].
Appare necessaria una riflessione storiografica che, da un lato, smonti la naturalità apparente degli assiomi putiniani («ci avete costretto») e, dall’altro, cerchi di reinserire nella concatenazione delle cause e degli effetti la soggettività, il momento della scelta politica e quindi della responsabilità per le decisioni assunte, superando lo stereotipo duro a morire di una cultura politica russa insieme monolitica e perennemente soggetta a un percorso di ‘occidentalizzazione’ oppure di ‘transizione democratica’, eterno apprendista condizionato da idee e azioni altrui. Offriremo di seguito un elenco di interrogativi su cui meriterebbe riflettere, esemplificati da pochi, volutamente scarni esempi.
2. Un prodotto delle relazioni internazionali?
L’intensificazione degli scambi a cui è stato dato il nome di globalizzazione ha messo in primo piano la politica internazionale, che ha finito quasi per sovrapporsi alla scienza politica tout court. Tuttavia assumere le relazioni internazionali come oggetto di analisi porta a concentrare l’attenzione sul rapporto tra stati come entità date, piuttosto che sforzarsi di osservare quanto avviene dentro gli stati, in particolare la sensibilità e gli schemi di lettura del reale, i modi di ‘vedere il mondo’ che si sviluppano autonomamente, prima e indipendentemente da trattati o trattative. È un punto di vista che tende ad appiattire i ‘paesi’ sui loro rappresentanti ufficiali, a darne per scontato il linguaggio come descrizione del reale, e quindi porta a sottovalutare il modo in cui le evoluzioni interne a ciascun contesto possono tracciare ciò che poi, in un negoziato, finisce per presentarsi come ‘linea rossa’ irrinunciabile.
È vero che la New Diplomatic History e gli orientamenti più aggiornati della storia delle relazioni internazionali hanno superato da tempo l’angustia della storia dei trattati in una più ampia storia delle interdipendenze, allargando notevolmente il ventaglio di fattori da considerare, dalla diplomazia culturale al ruolo dell’interscambio commerciale. Tuttavia anche le ricerche migliori, intente a ricostruire le radici interne degli orientamenti di politica internazionale, lasciano l’impressione di una sorta di asimmetria cognitiva o, per dirla con semplicità, una tendenza a fare i conti senza l’oste. Il gran lavoro di scavo nelle fonti statunitensi condotto da Mary Sarotte ha messo in luce il peso della politica interna americana nel determinare, ad esempio, l’abbandono del progetto di coinvolgimento della Russia post-sovietica nella partnership for peace. Tuttavia la parola “Russia” contenuta nel titolo di questo libro importante sembra denotare un oggetto passivo, più che un soggetto della concatenazione causale[8]. La domanda ricorrente nei dibattiti della diplomazia statunitense su chi o perché abbia ‘perso la Russia’ tradisce un certo egocentrismo metodologico. Il quadro delle interdipendenze non potrebbe essere completo se non si esaminasse con pari attenzione il significato che le medesime formule – partnership per la pace, ipotetico ingresso russo nella Nato, e poi ‘mondo multipolare’ (formula, quest’ultima, solo apparentemente neutra o ispirata da un ragionevole buon senso) – hanno assunto nei ragionamenti della classe dirigente russa dopo il 1991, soprattutto da Evgenij Primakov in poi.
La tesi di una Russia ‘aggredita’ dall’espansione della Nato (coincisa in realtà con una smilitarizzazione del continente europeo) e di un Putin incattivito e incupito perché ‘stretto nell’angolo’ e ‘circondato’ dalle azioni altrui, sottovaluta l’importanza del brodo di coltura di idee e sentimenti, spesso bizzarri o visionari, che però hanno finito per condizionare la mentalità e le scelte della classe dirigente russa. Uno tra i tanti esempi è l’utopia (non una Realpolitik, lo si noti) Il terzo impero di Sergej Jur’ev, testo ampiamente letto al Cremlino, che già nel2007 descriveva con incredibile precisione di dettagli gli eventi oggi in corso[9]. Se è vero che la dottrina immaginosa di Aleksandr Dugin non può essere assunta con superficialità a ideologia del regime, resta il fatto che i suoi Fondamenti della geopolitica (1997) da molto tempo sono testo di studio per gli ufficiali dello Stato maggiore[10], cioè i generali che oggi comandano le truppe sul campo. Se un giorno si indagheranno le origini russe della guerra nelle fonti inedite, bisognerà cercare la risposta in questi mondi, all’intersezione tra ambienti militari, entourage putiniano e galassia del pensiero di una destra che solo eufemisticamente può dirsi conservatrice, più che nei ragionamenti degli esperti internazionalisti della Higher School of Economics di Mosca.
Una riflessione sulle cause storiche della guerra non può esimersi dall’indagare a fondo la torsione – da spiegare storicamente – che avvenne nella sensibilità politica della classe dirigente russa già dalla seconda metà degli anni novanta: dall’idea della fine dell’Urss come opportunità, inizio di una ricerca proiettata verso il futuro di nuovi modi di definire un proprio orgoglio patriottico in quanto stato tra gli stati – esigenza non solo legittima, ma indispensabile per qualunque comunità politica, e che poteva assumere in pratica una varia gamma di forme più o meno autoritarie di nazionalismo russo non bellicista – alla rilettura del 1991 come tragedia nazionale, catastrofe da ribaltare nel riscatto e poi nel trionfo in un conflitto percepito in partenza – questo il punto fondamentale – su scala mondiale. Nona Mikhelidze ha descritto con efficacia, in un articolo giornalistico ma analiticamente rigoroso, i fattori anche economici e doganali che hanno accompagnato questo slittamento dalla prospettiva di una integrazione dello spazio post-sovietico intesa come cooperazione tra stati sovrani al progetto di una loro riconquista più o meno strisciante e indiretta[11].
Il contesto globale ha certo condizionato le decisioni. L’azzardo della guerra è stato favorito dalla percezione russa di un declino epocale dell’egemonia statunitense a partire dal 2006-2008 (e poi la mancata rielezione di Donald Trump e il ritiro dall’Afghanistan) e dalla cooptazione di settori influenti dell’élite tedesca e italiana nel sistema di interessi anche personali dell’oligarchia putiniana, di cui la nomina di Gerhard Schroeder nel Consiglio degli azionisti di Gazprom AG (2005) ha rappresentato solo l’episodio più visibile. Tuttavia il nesso causale dovrebbe essere invertito. Non è stata una (inesistente) minaccia militare all’integrità territoriale della Federazione russa (stato nato nel 1991) a produrre la guerra.
L’emersione di un’idea di stato russo fondata sull’unità primigenia dello spazio post-sovietico e post-zarista (un millenario «codice di civilizzazione»), idea articolata in una serie di varianti ideologiche che qui non è possibile illustrare, ha influenzato la definizione di quello che i teorici delle relazioni internazionali chiamano ‘interesse nazionale’. Ha portato ad assumere la riunificazione di questo spazio come fine di importanza vitale, pur se da perseguire per tappe e con duttilità tattica. Perciò l’eventualità anche solo ipotetica di un’adesione dell’Ucraina alla Nato, in realtà esclusa per ragioni normative e politiche già dal 2014, è potuta apparire come la fine di un sogno, l’interruzione di una traiettoria esistenziale, la prova che il figliol prodigo non sarebbe tornato mai più e quindi, in un certo senso, come distruzione di sé. Letto in questa prospettiva mentale, il consolidamento di uno stato ucraino indipendente, che effettivamente si stava realizzando dopo il 2014 in tanti modi non solo militari, con o senza la Nato, è diventato una minaccia diretta alla sovranità russa. Questo spiega il paradosso altrimenti incomprensibile di una invasione militare intesa, crediamo sinceramente, come autodifesa. Le idee contano, anche nel gioco solo apparentemente oggettivo degli interessi e della politica di potenza. Non tutto quanto accade nel mondo, nel bene o nel male, dipende da decisioni assunte a Washington e vi sono buone ragioni per riflettere sulle cause della guerra tenendo presente il vecchio dibattito tedesco sul primato della politica interna[12].
3. Geopolitica?
I luoghi della cronaca odierna portano immediatamente alla mente il passato in cui questi territori sono stati il teatro di fragili tentativi di costruzione statuale che interagivano con le ambizioni opposte di centri di potere più consistenti, ad esempio l’Etmanato cosacco tra Confederazione polacco-lituana e stato zarista nel Seicento o la breve stagione dell’Ucraina indipendente durante la guerra civile, tra potenza tedesca e Unione sovietica nascente. È comprensibile la tentazione di situare la guerra di oggi in un great game millenario che influenzerebbe il destino di queste ‘terre di mezzo’, anche etimologicamente definite dalla parola Ucraina, ovvero “regione di frontiera”[13]. Gli esempi del passato aiutano a comprendere il presente, ma solo come punto di partenza della riflessione.
Quando si leggono resoconti sul modo in cui le autorità putiniane cercano oggi di sovrapporre una classe dirigente nuova di insegnanti e militari, amministratori o medici inviati nei territori occupati con stipendi triplicati[14], sorge spontaneo il paragone con la ricostruzione di John P. LeDonne, vero tour de force di storia istituzionale, della strategia con cui le autorità zariste cooptarono, depotenziarono e infine subordinarono la democrazia militare degli ufficiali cosacchi di Zaporižžja dopo il trattato di Perejaslav[15]. Una bella lezione recente di Andrea Graziosi ha riepilogato come, tra gli anni venti e trenta del Novecento, dekulakizzazione, collettivizzazione forzata, carestia, epurazione del partito comunista ucraino, abbiano compiuto lo sradicamento e la sostituzione violenta di una classe dirigente locale[16].
Eppure le spiegazioni in termini di contesa tra potenze non chiariscono le ragioni di accelerazione o attenuazione dello scontro e soprattutto i modi specifici in cui questo avanzamento o ritiro di centri geopolitici si traduce in pratica. Non tutte le forme di esercizio del potere nello spazio geografico hanno la stessa valenza politica e le stesse conseguenze per l’esistenza umana. C’è differenza tra l’inclusione militare dell’Ucraina nel Lebensraum del Terzo Reich e la diffusione in questa stessa regione delle regole comunitarie europee. Se riteniamo, seguendo Reinhart Koselleck, che è il tempo storico a costituire lo spazio[17], e non viceversa, dobbiamo partire dal presupposto che la geografia di una Grande potenza (e quindi la sua relativa, presunta ‘umiliazione spaziale’ come fattore causale) non discende da un codice genetico avulso dai fatti storico-politici. Dipende. La storia conosce periferie coloniali che diventano centri (gli Stati Uniti), progetti imperiali che poi danno luogo a neutralismi di lunga durata (Svezia[18]), grandi ascese che sfociano nella catastrofe (la Germania dall’Impero guglielmino al 1945) e poi approdano a esiti non prescritti dalla relativa Sonderweg: una Repubblica federale tedesca largamente antimilitarista e la cui capitale, Berlino, oggi tutto è fuorché il luogo della purezza della razza. Grandi imperi pieni di violenza come quello britannico[19] hanno in fine accettato la sovranità delle loro colonie e perseguito altri modi per sublimare il desiderio di grandezza (Londra come piazza finanziaria). È un itinerario spaziale opposto a quello che caratterizza la fine dello stato zarista e poi, almeno nelle intenzioni di Putin, la traiettoria post-sovietica, una divaricazione che le categorie di impero o post-impero, da sole, non permettono di spiegare.
Né discende da una tassonomia di Piccole, Medie e Grandi potenze lo status permanente di frontiera lattimoriana[20], spazio intermedio tra centri geopolitici destinato a frantumarsi distruttivamente ogni volta che – e poiché, questo il punto su cui meriterebbe riflettere – i ‘grandi’ si scontrano. A volte anche gli interstizi della relativa epoca trovano la capacità di esprimere una classe dirigente determinata e competente che consente loro di diventare stati. Per questo ha poco senso affidarsi al tribunale degli storici per deliberare se e da quando, esattamente l’Ucraina sia diventata una ‘vera nazione’ con il diritto di esistere. A volte con successo, altre volte no, è la politica a costruire gli spazi di stato (nazionali o multi-nazionali che siano, autoritari o meno), non viceversa. L’arco cronologico e analitico in cui situare la ricerca delle cause della guerra in corso non può quindi che partire dagli ultimi anni dell’Urss e dalla sua crisi profonda. Sono cause radicate prima di tutto in traiettorie divergenti e poi antitetiche di costruzione della comunità politica (la litigiosa democrazia ucraina e la verticale del potere russa), più che nell’esistenza di spazi naturali di sicurezza o di esistenza nazionale.
Se, come ha notato di recente Mark Bassin, «geopolitical theories and models are always subjective, contingent, and profoundly malleable»[21], occorre avere il coraggio di guardare in faccia la loro virulenza deterministica. Non appare fuori luogo citare una fonte del nostro tempo, un lungo commento anonimo nell’infuocato dibattito digitale russo-ucraino che risale al 18 aprile del 2014, parole che chi scrive annotò allo scopo di intendere l’universo mentale, psicologico del conflitto. Il relativo video youtube non è più disponibile, per cui il lettore dovrà fidarsi della trascrizione.
Si può considerare con rispetto infinito la miope aspirazione di alcune persone per una libertà effimera e l’indipendenza, ma ahimè: la realtà della nostra vita è tale che oggi dinnanzi a voi, cittadini dell’Ucraina, sta il dilemma concreto di una scelta. O starete con la Russia, insieme alla quale nella storia avete respinto tataro-mongoli, svedesi, francesi, tedeschi; oppure le terre sulle quali ora vivete diventeranno la testa di ponte del folle calpestio di stivali degli interventisti occidentali, ricchi ma privi delle risorse naturali di cui dispone la Russia. E allora si ripeterà la spirale della storia: il “forno infuocato della guerra” si alimenterà con le infusioni delle finanze statunitensi, ma in quest’inferno ci sarete voi e i vostri figli. Da questo non c’è scampo, è la geopolitica!
«Non lo fò per piacer mio..», verrebbe da commentare per volgere contro la metafisica storica dello spazio la forza corrosiva della ragione ironica, che poi è il nostro pacifico Javelin. E dovrebbe risultare chiaro che per chi ragionava così, già nel 2014, l’ipotesi di uno stato ucraino neutrale non era un’opzione presa in considerazione.
4. Colonialismo: è la parola giusta?
«Non vivo più in un paese conquistato […]. Non è la Crimea a essere tornata a noi. Siamo noi che siamo tornati a casa. Nell’Urss»[22]. L’ambiguità tra conquista e liberazione che traspare da queste parole famose di una giornalista russa entusiasta dopo l’annessione della Crimea del 2014, suggerisce di riflettere più a fondo sull’utilità degli studi post-coloniali. In effetti il lessico coloniale è usato oggi nella retorica di entrambe le parti in conflitto, con un significato ovvio per le dichiarazioni ucraine e una surreale inversione tra parole e cose nel discorso putiniano, pure sorretto da una propria logica che bisogna sforzarsi di comprendere[23]. Entrambi gli usi (la rivendicazione dell’indipendenza ucraina e la putiniana insurrezione contro un mondo che impedisce alla ‘Russia’ di dominare e prevaricare) riflettono un clima culturale in cui si tende a dare per scontato che ‘colonialismo’ sia la forma di oppressione per eccellenza, sempre e ovunque. Sicché per combattere legittimamente contro un oppressore bisogna ad ogni costo assumere le sembianze della colonia altrui.
Lo zarismo ha conosciuto un proprio momento coloniale, soprattutto tra le riforme di metà Ottocento e il 1917, quando l’autoidentificazione (parziale) con gli imperi europei favorì uno sguardo analogo su alcune acquisizioni territoriali. Regioni come il Turkestan e il Caucaso meridionale effettivamente si prestano ad un’analisi comparativa delle società coloniali. Come ha mostrato Niccolò Pianciola, nella sovietica, gravissima carestia kazaca l’etica della gerarchia di consumo (la forma specifica della disuguaglianza e dello sfruttamento di uno stato comunista) si sovrappose a una gerarchia di regioni e popoli, con la conseguenza che i pastori nomadi dell’Asia centrale finirono per trovarsi, letteralmente, al fondo della catena alimentare[24]. Queste gerarchie etno-regionali del sacrificio collettivo sono ben visibili ancora oggi nel sistema di ‘quote’ della mobilitazione bellica, che colpisce più duramente dagestani o buriati e in generale le campagne più povere della Federazione russa.
Tuttavia l’impero zarista e poi l’Urss, in modo diverso, non conobbero una netta distinzione spaziale e culturale tra metropoli e colonie, bensì una gradazione di differenze di lingua, religione, stili di vita, istituzioni che intersecavano le discriminazioni cetuali o il privilegio socialista, gerarchie multiple subordinate al criterio principale della lealtà politica (sottomissione) a un potere monocratico (lo zar, il partito)[25]. Gli alti funzionari russi, armeni, ebrei o georgiani che vivevano a Mosca nella celebre Casa sul lungofiume narrata da Jurij Trifonov e studiata con un po’ di autocompiacimento da Yuri Slezkine[26], vera gated community della dirigenza sovietica, sapevano di poter essere arrestati e fucilati in ogni momento. Non era esattamente il centro di una metropoli coloniale.
Pare difficile trovare un concetto meno adatto a descrivere l’aggressione putiniana all’Ucraina dell’orientalismo saidiano, cioè l’alterizzazione descrittiva che colloca l’oggetto in una posizione di inferiorità culturale[27], concetto che la storiografia ha applicato per decenni, quasi con voluttà ai contesti più disparati. La lettura putiniana dell’Ucraina segue invece uno schema mentale opposto, che potremmo definire prepotenza dell’immedesimazione. Si basa cioè sull’assunto di un’unità originaria da ricomporre ad ogni costo, se necessario con la violenza estrema delle armi e referendum i cui organizzatori, per primi, sanno essere farseschi. L’Ucraina non è un Altro coloniale, ma sé. Presenta, semmai, analogie con il modo in cui Taiwan è vista nella cultura politica cinese, più che con il senso di superiorità della missione civilizzatrice europea. Non si tratta solo di rappresentazioni, l’oggetto della storia culturale. Questo modo di ragionare ha ricadute tangibili e quindi una valenza causale. Ad esempio, la convinzione che Russia e Ucraina fossero ‘una cosa sola’, che la sovranità indipendente di Kiev non potesse che assumere la forma caduca di uno ‘stato fallito’ creato artificiosamente da una ‘giunta golpista’, ha condizionato in modo molto concreto la strategia militare russa, con le conseguenze disastrose ben note.
Il tema merita certo una discussione più approfondita. Tuttavia vi sono ragioni sufficienti quanto meno per suggerire una linea di riflessione alternativa, sviluppando ulteriormente la problematizzazione di Frederick Cooper[28]. Invece di postulare l’esperienza del colonialismo europeo come cifra della storia mondiale, un dato che le generalizzazioni meno avvertite dilatano nel tempo di millenni e nello spazio globale, con la conseguenza di attribuire al lavoro dello storico il compito di cercare sempre e ovunque il modello di un dominio in verità di origine europea, soprattutto anglo-francese, potremmo applicare anche a questo concetto storico, non senza un pizzico di ironia, l’invito a «provincializzare l’Europa»[29]. Se pensiamo il colonialismo come un’esperienza storica che ha un inizio e una fine, limitata ad alcuni secoli, di importanza ovvia e cruciale per alcune aree, ma non per altre, diventa possibile concepire forme di dominio e di sfruttamento sociale non meno virulente e storicamente significative che però seguono una logica diversa e quindi vanno studiate nei loro specifici termini. Una maggiore sensibilità per queste differenze, che solo le storie di area possono rilevare, avrebbe reso la guerra meno imprevedibile.
5. La centralità della volontà politica
In una delle prime riflessioni su come la guerra abbia influenzato il modo di studiare la storia della Russia, Martin Aust ricordava l’interesse prevalente per «topics such as meaning creation, the power of discourses, and social practices» e suggeriva invece che «now seems the right time to return to the history of political decisions and address the problem of causality»[30]. In effetti sembra difficile leggere l’ultimatum putiniano del dicembre 2021 senza tener conto della radicalizzazione di una volontà soggettiva, una scelta imposta dall’alto – dallo stesso Putin e probabilmente da un gruppo relativamente ristretto di dirigenti – non solo all’Ucraina e alla comunità internazionale, ma anche ad ampi settori della classe dirigente e alla società russa, le cui reazioni iniziali sono state abbastanza simili allo sgomento attonito di Luk’janov ricordato in apertura. Il dato va collocato sullo sfondo di una tradizione russa in cui la volontà di cambiare il corso della storia ha sempre avuto un’importanza notevole e ricorrente. Non è un caso – l’esempio è solo apparentemente scollegato – che sia stato l’intellettuale russo emigrato e storico economico harvardiano Alexander Gerschenkron a introdurre nelle categorie della propria disciplina la nozione di ‘fattori sostituivi’ della crescita economica, ovvero la capacità della politica di accelerare lo sviluppo[31].
Per quanto ci si sforzi di ricostruire il gioco di azioni e reazioni internazionali che hanno condotto alla radicalizzazione dello scontro[32], il ruolo della volontà appare un fattore causale insostituibile. Se si guarda alla questione dal punto di vista del primato della politica interna sopra ricordato, cioè da Mosca, come spiegare con i criteri del realismo, della politica di potenza o di un generico patriottismo, pur se ‘ibrido’ o ‘illiberale’, decisioni che hanno già recato danni incalcolabili all’economia, alla risorsa strategica dell’esportazione di idrocarburi, alla stabilità della società e al funzionamento delle sue istituzioni (obiettivi originari della ‘stabilizzazione’ putiniana di inizio secolo), e hanno trasformato un esercito che si voleva riformato nella mobilitazione caotica di mandrie umane?Né appaiono sufficienti le spiegazioni che si basano sulla razionalità immanente, da Tucidide ai giorni nostri, di una balance of power theory applicata a prescindere dalla visione ideologica degli attori storici.
Vi è una dimensione utopico-religiosa nelle autorappresentazioni putiniane[33] che sfugge alla comprensione in termini di realismo conservatore, uno dei cliché interpretativi che hanno favorito la sottovalutazione di questo regime nuovo. Si manifesta non solo nelle decisioni estreme del leader, ma anche nelle rifrazioni della coscienza popolare. Anche in questo caso può essere utile osservare le fonti ‘basse’ del nostro tempo, ad esempio il videoclip patriottico sulle note del musicista Shaman (Lo sciamano) oggi popolarissimo in Russia, in cui la celebrazione di un culto del capo che si credeva sepolto nei regimi del passato riemerge con forza e si combina con una psicologia a suo modo apocalittica e rivoluzionaria: «Io sono russo. Andrò fino in fondo», a costo di provocare «una catastrofe globale»[34].Del resto lo slogan «Dio è con noi» ricorre frequentemente nel linguaggio politico russo odierno.
Vi è quindi da chiedersi se la guerra non segnali la necessità di portare al centro della ricerca storiografica l’attenzione per la politica anche nella sua dimensione di fede, convincimento non necessariamente suffragato da dati obiettivi, un fattore storico da inserire nella concatenazione causale e da comprendere nei suoi propri termini anche quando si presenta in forma asistematica, come insieme sincretico, persino cacofonico di idee-sentimento storicamente operanti. La guerra probabilmente richiede una sensibilità storiografica diversa, più tragica, da quella nata da un mondo che si credeva piatto e privo di ideologie: la storiografia di un’epoca che esige fermezza intellettuale.
Alberto Masoero
[1] Sergej Karaganov, Nato – eto rak, poka metastazy tol’ko rasprostranjajutsja (La Nato è un cancro e le sue metastasi iniziano a diffondersi), «Rossija v global’noj politike» (La Russia nella politica globale), 19 gennaio 2022, https://globalaffairs.ru/articles/nato-eto-rak/.
[2] Fëdor Luk’janov, Staroe myšlenie dlja našej strany i vsego mira (Un vecchio modo di pensare per il nostro paese e il mondo intero), «Rossija v global’noj politike», 2022 n. 2, https://globalaffairs.ru/articles/staroe-myshlenie/.
[3] Cfr. testo e commento dell’intervento di Akropov in Alberto Masoero, Oltre l’Ucraina. Le ambizioni di una guerra, «L’Indice dei libri del mese», 2022, n 4, pp. 16-17, https://www.lindiceonline.com/geografie/lavanzata-della-russia-e-del-nuovo-mondo/; Timofej Sergejcev, Čto Rossija dolžna delat’ s Ukrajnoj? (Cosa deve fare la Russia dell’Ucraina?), «RIA Novosti», 3 aprile 2022; cfr. la traduzione inglese: https://medium.com/@kravchenko_mm/what-should-russia-do-with-ukraine-translation-of-a-propaganda-article-by-a-russian-journalist-a3e92e3cb64.
[4] Sulle radici della volontà russa di rappresentare un centro ideologico mondiale, cfr. Alberto Masoero, Russia between Europe and Asia, in The Boundaries of Europe. From the Fall of the Ancient World to the Age of Decolonization, ed. Pietro Rossi, Berlin, De Gruyter, 2015, pp. 175-208.
[5] Vladimir V. Putin, Mineral’no-syr’evye rezursy v strategii razvitija rossijskoj ekonomiki (Le risorse delle materie prime minerali nella strategia di sviluppo dell’economia russa), «Zapiski Gornogo instituta» (Memorie dell’Istituto minerario), 144, 1999, pp. 3-9; Dmitrij Rogozin, Ekonomičeskaja vojna (Guerra economica), «Zavtra» (Domani), n. 22, 1 giugno 2005, https://zavtra.ru/blogs/2005-06-0131.
[6] War and the State of the Field, «Ab Imperio», 2022 n. 1, p. 9.
[7] Marco Puleri, Vanessa Voisin, Usi e abusi della storia. La Russia e l’Ucraina secondo Putin, «Doppiozero», 1° marzo 2022, https://www.doppiozero.com/la-russia-e-lucraina-secondo-putin.
[8] Mary E. Sarotte, Not One Inch. America, Russia, and the Making of the Cold–War Stalemate, New Haven, Yale University Press, 2021.
[9] Sergej Jur’ev, Tret’ja imperija. Rossija kotoraja dolžna byt’ (Il terzo impero. La Russia che dev’essere), Moskva, Limbus Press, 2007.
[10] Aleksandr G. Dugin, Osnovy geopolitiki, Moskva, Arktogeja, 1997.
[11] Nona Mikhelidze, Un’Ucraina europea la vera paura di Putin, «La Stampa», 9 agosto 2022, pp. 16-17.
[12] Ad esempio la riedizione di un noto classico: Fritz Fischer, From Kaiserreich to Third Reich. Elements of Continuity in German History, 1871-1945, London, Routledge, 2020.
[13] È la prospettiva adottata da Giorgio Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina, Roma, Carocci, 2021.
[14] Andrey Pertsev (Andrej Percev), Outpost state, «Riddle», 5 agosto 2022, https://ridl.io/outpost-state/
[15] John P. LeDonne, Forging a Unitary State: Russia’s Management of the Eurasian Space, 1650-1850, Toronto, University of Toronto Press, 2020.
[16] Andrea Graziosi, Holodomor: la carestia sovietica in Ucraina, «LiberiOltre», 2 aprile 2022, https://www.youtube.com/watch?v=wH6KyEHVN_0&ab_channel=LiberiOltre.
[17] Reinhart Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2000, p. 9.
[18] Michael Roberts, The Swedish Imperial Experience 1560-1718, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.
[19] Lauren Benton, Evil Empires? The Long Shadow of British Colonialism, «Foreign Affairs», July–August, 2022, pp. 1-23.
[20] Owen Lattimore, La frontiera. Popoli e imperialismi alla frontiera tra Cina e Russia, Torino, Einaudi, 1970.
[21] Mark Bassin, “Everything Is Revealed in Maps”: The European Far Right and the Legacy of Classical Geopolitics, «Geopolitics», 2022, p. 19.
[22] Ul’jana Skobejda, Ja bol’še ne živu v zavoevannoj strane (Non vivo più in un paese conquistato), «Komsomol’skaja pravda», 25 marzo 2014, https://www.kp.ru/daily/26210/3095671/.
[23] Cfr. le argomentazioni anticoloniali in Vladimir V. Putin, Signing of treaties on accession of Donetsk and Lugansk people’s republics and Zaporozhye and Kherson regions to Russia, 20 settembre 2022, http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/69465.
[24] Niccolò Pianciola, Sacrificing the Qazaqs: The Stalinist Hierarchy of Consumption and the Great Famine of 1931–33in Kazakhstan, «Journal of Central Asian History», 2022, n. 1, pp. 225-72.
[25] Cfr. il nesso ideologico profondo tra autocrazia e integrità territoriale dello stato in Richard Wortman, The “Integrity” (Tselost’) of the State in Imperial Russian Representation, «Ab Imperio», 2011 n. 2, pp. 20-45; sulla cultura politica autocratica come limite all’adozione di una prospettiva coloniale, cfr. Alberto Masoero, Territorial Colonization in Late Imperial Russia. Stages in the Development of a Concept, «Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History», 14, 2013, pp. 59-91.
[26] Jurij Trifonov, La casa sul lungofiume, Roma, Editori Riuniti, 1977; Yury Slezkine, La Casa del governo : una storia russa di utopia e terrore, Milano, Feltrinelli, 2018.
[27] Edward W. Said, Orientalism, London, Routledge, 1978.
[28] Frederick Cooper, Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, Berkeley, University of California Press, 2005.
[29] Dipesh Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, Roma, Meltemi, 2004.
[30] Martin Aust, Vision and Horror: Eastern European History in Germany from the Fall of the Berlin Wall in 1989 to Russia’s Attack on Ukraine in 2022, «Ab Imperio», 2022, n. 1, p. 102.
[31] Alexander Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, Torino, Einaudi, 1974.
[32] Un utile riepilogo in Adam Tooze, Putin’s Challenge to Western Hegemony, «Chartbook # 68», 12 gennaio, 2022, https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-68-putins-challenge-to.
[33] Cfr. tra i numerosi esempi il riferimento al concetto di ‘passionarietà’ (passionarnost’) di Lev Gumilëv, già nel 2012: Vladimir V. Putin, Poslanie Prezidenta Federal’nomu Sobraniju (Indirizzo del presidente all’Assemblea federale), Prezident Rossii, 12 dicembre 2012, http://kremlin.ru/events/president/news/17118; la migliore monografia sul tema è Mark Bassin, The Gumilev Mystique. Biopolitics, Eurasianism, and the Construction of Community in Modern Russia, Ithaca, Cornell University Press, 2016, pp. 43-59.
[34] Shaman, Ja russkij. Putin (Io sono russo. Putin), https://www.youtube.com/watch?v=gFG_-VB7Dlo&ab_channel=IrinaAgheeva.