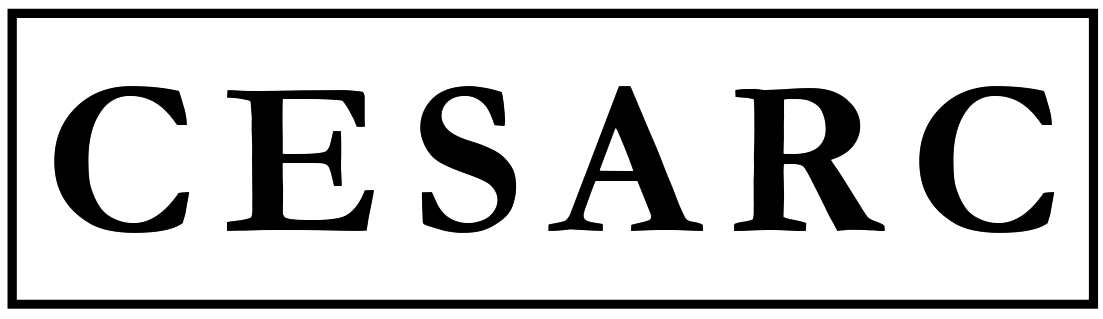Lev Tulskij
Russia, 20 ottobre 2025
La brace sotto la neve
In Russia, il silenzio non è mai solo silenzio.
Sotto la crosta dei discorsi ufficiali e delle liturgie patriottiche, continua a covare una brace viva: quella di una fede che non si arrende alla retorica della vittoria e non confonde il Vangelo con la geopolitica.
È la fede nascosta, spesso anonima, dei sacerdoti sospesi, delle donne che pregano in cucina, dei giovani che scrivono “Не убивай — non uccidere” sui muri dell’università.
Questa brace arde anche quando l’apparato ecclesiastico, saldato al potere politico, parla con voce di tuono e benedice le armi.
Eppure, sotto la cenere della paura, continua a resistere l’umile tepore del Vangelo.
Navalnyj e la liturgia della libertà
Il giorno dei funerali di Aleksej Navalnyj resterà come un taglio nella memoria della Russia contemporanea. Era marzo, ma la città era ancora avvolta da una neve che non scioglieva il dolore. Migliaia di persone portavano fiori e candele. Nessuno gridava slogan: il silenzio era già protesta. In mezzo a quella folla, un prete ha compiuto un gesto che sembrava impossibile: celebrare il funerale di colui che il potere definiva “traditore”. Si chiamava padre Dmitrij Safronov.
Ha letto le preghiere con voce calma, senza retorica, e quando ha tracciato il segno della croce sul feretro, la sua mano tremava come quella di chi sa di rischiare tutto.
In quella chiesa, per qualche ora, la Russia ha riscoperto la lingua della libertà. Un mese dopo, il Patriarca Kirill lo ha sospeso per tre anni dal ministero sacerdotale, con la formula burocratica di “violazione delle regole liturgiche”.
Ma la vera colpa di Safronov era un’altra: aver restituito al cristianesimo russo un gesto di compassione in un tempo di propaganda. A lui si unì idealmente l’arciprete Aleksej Uminskij, rimosso pochi mesi prima per essersi rifiutato di recitare la “preghiera per la Santa Rus’ e la vittoria”.
Sono diventati, loro malgrado, i simboli di un clero che non vuole essere suddito.
Due teologie, una sola patria
Nel cuore dell’ortodossia russa convivono oggi due teologie inconciliabili.
La prima è quella ufficiale: parla di “Santa Rus’” e di “guerra sacra”. Benedice i carri armati, celebra Aleksandr Nevskij come archetipo del sovrano guerriero, costruisce templi monumentali per i “difensori della patria”. È la teologia del potere, che trasforma il martirio in strategia di comunicazione e la liturgia in coreografia militare. La seconda, più silenziosa, è quella della Chiesa sommersa: prega in case private, accende candele davanti a icone senza cornice, cita i profeti invece dei generali. È una teologia della coscienza, della compassione, della nonviolenza.
È la fede dei sacerdoti sospesi, delle donne che leggono il Vangelo nelle cucine, dei monaci costretti a lavorare come giardinieri, dei giovani che rischiano l’espulsione per aver detto “pace” ad alta voce.
Due Russie si affrontano dentro la stessa liturgia: quella del potere e quella della misericordia.
Il culto del potere e la nuova idolatria
La grande processione per Aleksandr Nevskij, ogni settembre a San Pietroburgo, è ormai il manifesto di una religione patriottica.
Nel 2025 più di settantamila persone hanno percorso la Nevskij Prospekt: icone, tricolori, cosacchi, reggimenti, cori sacri.
Il santo principe che difese la patria nel XIII secolo è diventato simbolo di una “guerra santa” contro l’Occidente, riedizione spirituale della geopolitica imperiale.
Ma pochi ricordano che Nevskij fu anche un diplomatico, non solo un crociato.
Intorno alla sua figura il potere ha costruito una nuova teologia dell’obbedienza: una fede che serve il trono, non la verità.
E il Patriarcato di Mosca, saldato al Cremlino, ha assunto il ruolo di garante simbolico di questa alleanza.
Un esempio è la costruzione di chiese dedicate alla “SVO”, l’“operazione militare speciale”. A Puškin, vicino a San Pietroburgo, è stato approvato un tempio di trenta metri, “in onore dei difensori della patria”.
Ma i cittadini hanno protestato: “Un tempio della guerra è una bestemmia”.
È successo in Russia, non in una diaspora di dissidenti all’estero.
Anche questo dice che la fede non è morta: si è spostata di lato, fuori dai circuiti del potere.
Le lettere alle madri
Il Patriarca Kirill ha lanciato nel 2024 una campagna di lettere alle donne incinte, lodandole come “speranza della nazione”.
È una pastorale che diventa biopolitica: la vita come risorsa strategica, la maternità come servizio alla patria. La parola “amore” è sostituita da “valori tradizionali”, la parola “giustizia” da “stabilità”. Ma la retorica della nascita non cancella la realtà della morte. Nelle campagne, le madri pregano in silenzio per i figli che combattono al fronte, e non rispondono più alle circolari del Patriarcato. La propaganda chiama “speranza” ciò che in molte case è diventato lutto.
I preti della pace
In questa Russia divisa, c’è un documento che continua a circolare come una reliquia di libertà. Nel marzo 2022, 294 sacerdoti ortodossi firmarono una lettera pubblica contro la guerra: “Ogni popolo è fratello di un altro popolo. Non si può difendere la verità con la violenza”. A distanza di tre anni, il testo è ancora accessibile sul web russo — un piccolo miracolo digitale in un Paese dove la censura riscrive tutto.
Da quella lettera è nato il fondo “Mir vsèm” – “Pace a tutti”, che sostiene i chierici sospesi, le loro famiglie e le parrocchie colpite dalle purghe ecclesiastiche.
Ogni mese pubblicano l’elenco dei “sacerdoti del silenzio”, e la lista si allunga.
Fra loro, padre Ioann Kurmojarov, ieromonaco di San Pietroburgo condannato per “discredito dell’esercito”. Dopo due anni di colonia penale, è stato liberato ad agosto 2025 e subito inserito nel registro degli “agenti stranieri”.
Sorride comunque: “Forse sì — sono un agente. Ma dell’unico regno che non ha confini, quello della pace”. Questi uomini non fanno politica: semplicemente ricordano che il Vangelo non ha partito. Ed è proprio per questo che fanno paura.
Le donne e la fede della pietra
A Mosca, Ekaterinburg, Kazan’, le “femministe credenti” organizzano preghiere pubbliche per la pace.
Il 7 aprile, festa dell’Annunciazione, si radunano in piccoli gruppi, con icone e candele. Sui loro cartelli si legge: “Maria ha detto sì alla vita, non alla violenza”. Non chiedono riforme: testimoniano. Le loro liturgie si celebrano in cucine, cortili, biblioteche. Lì dove il potere costruisce cattedrali di bronzo, loro accendono semplici candele di cera. Nella loro mitezza, contraddicono il potere più di mille comizi. È una religione domestica, popolare e teologica al tempo stesso. E forse è proprio qui che la Chiesa russa ritrova la sua anima più antica: quella dei tempi in cui la fede sopravviveva nei villaggi, mentre le autorità predicavano ateismo di Stato.
Il Vangelo e la propaganda
Il Patriarcato parla di “vittoria spirituale”, ma la parola più evangelica che oggi si possa pronunciare in Russia è una sola: No.
“No alla guerra, alla menzogna, al culto del potere”. Nei villaggi, i parroci commentano il Vangelo del giorno con prudenza. Quando leggono “Non potete servire Dio e la violenza”, tutti capiscono chi stanno nominando senza nominarlo.
E chi ascolta, uscendo, è un po’ più libero di quando è entrato. In quelle omelie c’è un’eredità segreta della dissidenza religiosa del Novecento: da Florenskij a Bulgakov, da Solov’ëv a Berdjaev.
Tutti avevano previsto il rischio di un cristianesimo statalista, ridotto a simbolo identitario. Oggi quel rischio è tornato realtà.
La croce e la bandiera
C’è un proverbio russo che dice: “La candela più piccola illumina anche la chiesa più buia”. Oggi, quella candela è accesa dai pochi che resistono al buio del potere. Il Patriarcato ha scelto di erigere un cristianesimo con la croce privata della compassione e riportata a segno costantiniano di vittoria: una croce che non abbraccia, ma marchia; un simbolo che non redime, ma distingue. È un cristianesimo con la bandiera, non con la coscienza. E la bandiera — come recita un verso satirico russo — “è il simbolo della statalità / che si regge sul bastone”. Nel lontano 1872, il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli condannò questa deviazione con un nome preciso: filetismo, o etnofiletismo, l’eresia di chi fa coincidere la fede con la nazione.
Il filetismo, ricordava il Sinodo, non è solo un errore politico: è una negazione del Vangelo stesso, perché trasforma la Chiesa in frontiera e Cristo in identità collettiva.
Ma troppi, oggi, lo hanno dimenticato.
Il tempio e la prigione
Nel tempio principale delle Forze Armate, alla periferia di Mosca, i mosaici raffigurano Stalin, Putin e l’icona di Cristo con la spada sguainata.
È la sintesi perfetta di un cristianesimo divenuto ideologia di potenza.
Ma fuori da quel tempio — nelle carceri, nelle province, nei monasteri lontani — continua a vivere un’altra liturgia: quella dei prigionieri, delle madri, dei poeti.
Uno di loro, un giovane volontario, mi ha scritto: “Se non posso andare in chiesa, accendo una candela davanti allo schermo del telefono e prego per chi non può farlo più”. È la nuova forma del culto sotterraneo.
La fede digitale, clandestina, che non chiede permessi e non teme scomuniche. Una Chiesa che non ha mura, ma resiste dentro il cuore dei credenti.
La grazia del dissenso
Ogni regime teme due cose: la memoria e la preghiera.
La memoria perché restituisce ai morti la loro voce.
La preghiera perché spezza la paura, e un popolo che prega liberamente è un popolo che non obbedisce più. Per questo il potere cerca di controllare entrambe.
Cancella i libri e i canti, chiude i monasteri “troppo indipendenti”, punisce i sacerdoti che benedicono funerali non autorizzati.
Ma la grazia del dissenso è più forte della repressione.
Scrivo queste righe da una Russia che continua a pregare anche per chi la condanna. So che la fede non basta a cambiare la storia, ma la salva dal cinismo. E so che l’ultima parola, anche qui, sarà “pace”. Forse non subito, forse non nella lingua del Patriarca, ma in quella dei figli che non vogliono più morire. Lì, nel segreto delle case, nella preghiera delle madri, nella penna dei sacerdoti banditi, la speranza russa resiste. Non è una fede trionfante, né perfetta: è una fede ferita, è come non mai una fiammella intimorita e tremante. Ma proprio per questo parla al mondo intero. E forse è proprio dalle ferite che la Russia potrà rinascere.