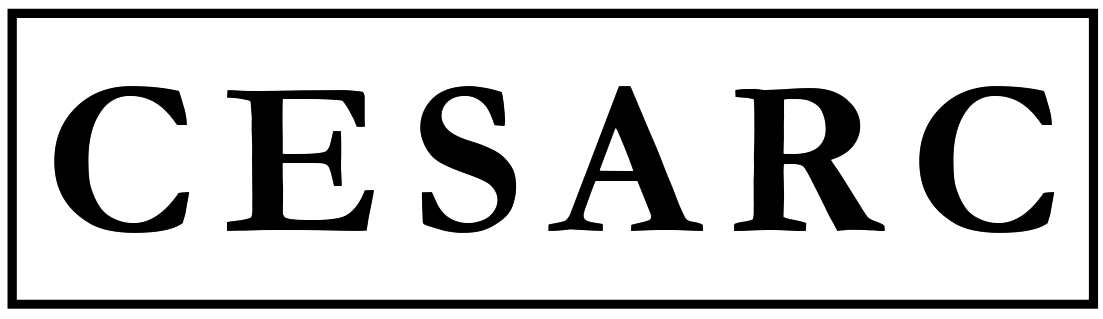Foto di Maxim Shipenkov/Ansa
Dal 2023, il corso “Fondamenti della statualità russa”, promosso su iniziativa del Cremlino, è diventato obbligatorio per tutti nuovi iscritti alle università della Federazione Russa. Il suo obiettivo dichiarato è la formazione di una “corretta” coscienza civica all’interno dell’ambiente universitario.
Ma come si svolge realmente questo corso, nella pratica quotidiana dell’aula universitaria? Il sito Republic.ru ha chiesto a una docente del corso di raccontare in prima persona come le direttive dei vertici si scontrano con la realtà, quali sono le reazioni degli studenti alla propaganda e se sia oggi possibile intrattenere un dialogo onesto in università senza rischiare il posto di lavoro. Il nome della docente non viene divulgato per motivi di sicurezza.
Perché ho accettato di insegnare
Nel 2021 ho iniziato a insegnare presso il dipartimento di Storia della Russia. Nei primi due anni il mio carico didattico è stato piuttosto ridotto: la maggior parte degli insegnamenti era stata già da tempo affidata a docenti titolari.
Tutto è cambiato al terzo anno, quando è stata introdotta per gli studenti del primo anno una nuova disciplina: “Fondamenti della statualità russa”. Nel nostro dipartimento si è reso disponibile un numero considerevole di ore di lezione, che andavano necessariamente distribuite tra i vari docenti. Ritenevo che anche il corso promosso con le finalità più bizzarre potesse essere adattato alle mie modalità didattiche e, cosa ancor più importante, alle esigenze degli studenti. A quel punto, avevo già avuto un’esperienza positiva nell’insegnamento di un corso piuttosto inutile e mal sopportato dalla maggioranza degli studenti di storia, quello di “Studi regionali”, e questo mi incoraggiava a mettermi in gioco anche con la nuova materia.
Quando per la prima volta mi sono confrontata con il programma del corso e con il manuale metodologico, non ho provato particolare stupore. Nelle scuole erano già stati introdotti i “Colloqui sui temi fondamentali” (Nota di traduzione: i “Razgovory o važnom” sono lezioni settimanali introdotte dal 2022 nel sistema scolastico russo, di contenuto ideologico e con l’obiettivo di rafforzare i “valori patriottici e morali” dei giovani. Si tengono normalmente ogni lunedì mattina, in apertura della settimana scolastica, sulla base di materiali didattici forniti regolarmente dal Ministero) e presupponevo che i “Fondamenti della statualità russa” ne sarebbero stati l’equivalente universitario. E così è stato.
Dopo aver esaminato i materiali, ho provato un certo sollievo: si trattava di contenuti con cui era possibile lavorare. Per esperienza sapevo che gli studenti raramente si interessano alle linee guida metodologiche o ai programmi di corso, e che aprono il manuale soltanto se esplicitamente richiesto (tanto più che nel nostro caso era disponibile solo in formato elettronico, il che ne rendeva l’utilizzo ancora meno agevole). A un primo sguardo, la struttura del corso appariva innocua.
Il corso era suddiviso in cinque moduli: “Cos’è la Russia”, “Lo Stato russo come civiltà”, “La visione del mondo russa e i valori della civiltà russa”, “L’ordinamento politico”, “Le sfide del futuro e lo sviluppo del Paese”. Fin dall’inizio ho cercato di pianificare come introdurre ogni sezione nella prima lezione, in modo da far comprendere agli studenti che il nostro corso avrebbe avuto un’impostazione storico-culturale piuttosto che ideologica.
Il conflitto ideologico
Le mie convinzioni personali, sia storiche sia politiche, non coincidevano affatto con quanto previsto dai contenuti ufficiali del corso. Non era una sorpresa: il responsabile della sua ideazione non era uno storico, bensì un esperto di comunicazione politica, l’attuale prorettore della RANEPA (Accademia presidenziale russa di economia nazionale e pubblica amministrazione), Andrej Polosin.
Il corso riflette il putinismo ormai consolidato in Russia, con il suo bizzarro intreccio di idee conservatrici e nazionalistiche: postula l’esistenza di un’identità “russa” quale fondamento dell’autocoscienza collettiva, promuove un’opposizione netta all’“Occidente corruttore”, manifesta preoccupazione per la sorte dei “valori tradizionali” e si nutre di teorie complottistiche. Tutto ciò mi è profondamente estraneo.
Prima dell’inizio dell’anno accademico, noi docenti incaricati di tenere questo corso siamo stati convocati dal prorettore alla didattica e alla qualità dell’istruzione. Tuttavia, non si è trattato di un vero confronto: il prorettore ha pronunciato un monologo nel quale ha illustrato quelle che secondo lui erano “alcune direttive fondamentali”.
In primo luogo, l’intero corso avrebbe dovuto trasmettere in modo coerente l’idea che la Russia è impegnata in una lotta giusta, mentre l’Occidente collettivo e l’“Ucraina marionetta” sono nostri nemici. In secondo luogo, ogni tipo di discussione all’interno del corso era da ritenersi inammissibile: il docente doveva limitarsi a trasmettere con precisione i messaggi predefiniti, scegliendo accuratamente le parole per non insinuare alcun dubbio nelle menti degli studenti. In terzo luogo, ci veniva raccomandata estrema cautela: erano possibili ispezioni, e tra gli studenti potevano trovarsi figli di funzionari pubblici o di appartenenti alle forze di sicurezza, che “in caso di problemi” avrebbero potuto riferire ogni cosa ai genitori.
“L’istinto statale sviluppato”
Il massimo conflitto interiore, come storica, l’ho provato di fronte al secondo modulo del corso: “Lo Stato russo come civiltà”. L’idea centrale che lo attraversa è l’esistenza di una civiltà russa particolare, dotata di un’identità unica e inimitabile. Gli autori del corso sostengono che il tratto distintivo di una civiltà sia il grado del suo “radicamento nella storia”, e in tal senso — si afferma — la Russia non avrebbe rivali. I Paesi vicini, al contrario, sarebbero privi di simile profondità storica: “Solo in seguito, col senno di poi, cercheranno di sostenere l’esistenza originaria, secolare, della propria nazione, rintracciando antenati mitologici e costruendo una memoria storica nazionale — secondo le capacità dei rispettivi ideologi”.
Il modulo elenca quelli che vengono definiti “blocchi costitutivi” della civiltà russa: l’armonia tra la Chiesa ortodossa e il potere secolare, un “istinto statale” sviluppato, la capacità del popolo di unirsi per una causa comune, la misericordia e la giustizia del sovrano ortodosso nei confronti dei popoli non russi e degli appartenenti ad altre fedi, e così via. Certo, la “civiltà” si trova di tanto in tanto ad affrontare delle sfide, ma le supera sempre con successo.
Di “blocchi costitutivi” come la servitù della gleba, le rivolte del XVII secolo, il conflitto tra Stato e Chiesa (sfociato nella sottomissione di quest’ultima), i colpi di palazzo — nessuna traccia. Particolarmente sconcertante è stata l’affermazione sul contributo dei Decabristi: “Un notevole apporto allo Stato come studiosi della Siberia e di altre regioni dell’Impero”. Davvero sorprendente!
Gli autori del corso aggirano abilmente gli episodi scomodi. Del protocollo segreto allegato al patto Molotov-Ribbentrop, che prevedeva la spartizione delle sfere d’influenza in Europa, non si fa menzione alcuna. Ci si limita a scrivere: “Hitler attaccò la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale”.
Naturalmente, nel contesto del corso ero costretta a presentare questi contenuti in altro modo. Non volevo mentire, né tantomeno ingannare gli studenti. Parlare di una “civiltà russa unitaria” è già di per sé problematico, figuriamoci proclamare la sua eccezionalità, la sua missione salvifica o la sua purezza storica.
Il problema principale non sta tanto nell’abbondanza di dati imprecisi (che pure non mancano), quanto nel modo in cui i contenuti sono stati selezionati, interpretati, incorniciati da allusioni, sentenze solenni e critiche edulcorate anche delle pagine più tragiche della storia. Alcuni aspetti vengono deliberatamente omessi, altri presentati come marginali, altri ancora accompagnati da “conclusioni sagge”. Il risultato non è un corso di studi, bensì un miscuglio di fatti, opinioni, stereotipi e miti che cerca di sembrare verità.
La strategia della “resistenza silenziosa”
Avevo una mia personale visione su come impostare il corso in modo da provare a lasciare fuori dall’aula i suoi tratti più ideologici. In ogni modulo affrontavamo contenuti reali e utili sulla Russia: geografia, storia, cultura, ordinamento politico. Invece di assegnare relazioni su presunti “eroi della Russia” dalla dubbia statura morale, proponevo agli studenti di lavorare in gruppo per preparare presentazioni su figure di spicco provenienti da diversi ambiti, lasciando a loro la libertà di scegliere chi ritenessero meritevole. Al posto della visione obbligatoria di video chiaramente propagandistici del progetto “DNA della Russia”, proponevo un’attività di analisi critica: individuare le distorsioni dei fatti e discuterne insieme. Organizzavamo dibattiti sulla forma di governo più adatta alla Russia, discutevamo i problemi dello Stato e le modalità con cui ciascuno avrebbe potuto dare il proprio contributo per risolverli. Una grande fortuna è che le direttive calate dall’alto non solo vengono attuate male, ma sono anche scarsamente controllate: in due anni di insegnamento del corso, non ho mai ricevuto una sola visita ispettiva.
La reazione degli studenti
Il mio corso era rivolto a studenti iscritti a facoltà non umanistiche. La maggior parte di loro si presentava con la convinzione che il corso di Fondamenti della statualità russa fosse puro lavaggio del cervello e una materia del tutto inutile. Tuttavia, gli studenti più attenti capivano già dalla prima lezione che io stavo dalla loro parte — non da quella di chi aveva concepito e imposto il corso. Ed è proprio per questo che apprezzavano il mio approccio. Alcuni si sentivano liberi di esprimere apertamente posizioni di opposizione. Un ragazzo, in particolare, al termine di una lezione venne a parlarmi per esprimere le sue critiche al manuale del corso: lo indignava il fatto che tra gli autori dei materiali figurasse anche un teologo.
Non sono mancati tentativi, da parte degli studenti, di mettere alla prova i limiti di ciò che era consentito. Uno di loro dichiarò di voler presentare una relazione su Tesak come “figura di rilievo” (NdT: Tesak – letteralmente “Ascia” – era lo pseudonimo di Maksim Sergeevič Marcinkevič, attivista neonazista ed influencer, morto in carcere nel 2020) sperando probabilmente di mettermi in difficoltà e, in tal modo, eludere l’incarico. Con sua evidente sorpresa, gli concessi di procedere. Non sembrava aspettarselo a tal punto che non si era nemmeno preparato adeguatamente. Dopo il suo intervento, offrii un commento critico e precisai che anche i temi provocatori andavano affrontati seriamente — se non altro per avere una base di discussione.
Alcuni studenti erano talmente abituati alla formalità meccanica dell’istruzione da esserne talvolta ingannati. Una volta assegnai un esercizio: preparare un intervento sui fondamenti dell’ordinamento costituzionale russo, con un’analisi delle difficoltà della sua applicazione concreta. Quasi tutti svolsero il compito in modo eccellente, ma una studentessa, probabilmente, si limitò a scaricare un testo già pronto e non lo lesse neppure in anticipo. Ne risultò un’esposizione in cui la Russia appariva come una gloriosa democrazia con istituzioni pienamente funzionanti. Leggeva il suo testo tra i sorrisi trattenuti del pubblico, poiché molte delle affermazioni contraddicevano quanto avevamo già discusso a lezione. Alla fine, con imbarazzo, aggiunse che in realtà non era d’accordo con quanto aveva appena letto, ma non aveva fatto in tempo a preparare qualcosa di proprio.
L’atteggiamento verso la guerra tra studenti e docenti
Tra gli studenti non esisteva una posizione univoca rispetto alla guerra, e questo si rifletteva in una certa cautela e in reazioni indirette. Nessuno si esprimeva apertamente a favore del conflitto o degli obiettivi dichiarati dalle autorità, ma anche le dichiarazioni esplicitamente pacifiste erano rare. Credo che questa prudenza si spieghi con diversi fattori. In primo luogo, gli studenti temono le conseguenze legate a opinioni di dissenso. Nei miei corsi non si sono verificati episodi simili, ma all’interno dell’università sono noti casi di sanzioni per affermazioni di critica. Le direzioni di facoltà e di ateneo ricordano regolarmente il divieto di critiche pubbliche. In secondo luogo, le matricole, ancora impegnate nel processo di socializzazione in un ambiente nuovo, tendono a evitare conflitti e temono possibili delazioni. In terzo luogo, molti non hanno una posizione chiara: le questioni di politica estera appaiono complesse e lontane, mentre la retorica patriottica, già familiare dalla scuola, suscita più spesso apatia che interesse. Sono invece molto più inclini a discutere i problemi interni. Li preoccupano la quotidianità e le opportunità che si restringono: la scomparsa dei marchi preferiti, la riduzione della mobilità accademica, le difficoltà a viaggiare all’estero, la rottura dei legami con amici ucraini con cui prima si scrivevano o giocavano online. Su questo sfondo, il mio messaggio principale — che la guerra è una tragedia e non può essere considerata ammissibile — non ha mai suscitato obiezioni. Penso che su questo tutti fossero d’accordo, e da lì in poi ciascuno decideva da sé come comportarsi. So che alcuni dei miei studenti si sono poi attivati a sostegno della guerra, impegnandosi nella raccolta di aiuti umanitari o nella realizzazione di reti mimetiche per i soldati dell’“Operazione militare speciale”. Non c’è da stupirsi: oggi simili attività vengono attivamente presentate come espressioni autentiche di patriottismo.
Livello delle conoscenze
Purtroppo, il livello generale delle conoscenze tra gli studenti era piuttosto mediocre. Molti ignoravano nozioni che avrebbero dovuto essere consolidate già a livello scolastico. Per esempio, una delle pochissime date che suscitava un immediato riconoscimento era il 988 — il battesimo della Rus’. Non di rado, gli studenti non erano in grado di rispondere nemmeno a domande elementari di geografia: con quali paesi confina la Russia, quali mari e oceani la bagnano, e simili. Si tratta, ovviamente, delle conseguenze di un sistema educativo che, per molte ragioni, non fornisce un sapere strutturato e coerente. Detto ciò, non posso affermare di aver lavorato con studenti deboli o privi di motivazione. Molti di loro leggevano testi ben al di là del programma scolastico — autori come Limonov o Pelevin — e guardavano buon cinema, anche quello di Tarkovskij o Ioseliani.
I colleghi e il dipartimento
La maggior parte dei docenti del nostro dipartimento si presenta, almeno in pubblico, come sinceramente devota allo Stato. Durante le riunioni di facoltà, ogni frase intrisa di patriottismo del direttore del dipartimento viene accolta da un coro di cenni approvanti, e sembra che tutti considerino sinceramente il corso di Fondamenti della statualità russa una disciplina necessaria per educare al patriottismo. A volte era inquietante immaginare cosa potessero proporre i colleghi durante le loro lezioni. Una volta mi capitò l’occasione di scoprirlo: mi chiesero di sostituire un docente al primo seminario del semestre e di raccogliere i compiti assegnati — delle relazioni scritte. La sorpresa fu notevole quando gli studenti di matematica, che con fatica riuscivano a orientarsi nei fatti più elementari sulla Russia, iniziarono a leggere relazioni su temi come: “Il fattore russo nel processo storico mondiale”, “Il significato della posizione geopolitica della Russia e il processo della sua formazione”, “La posizione geopolitica di un soggetto della Federazione Russa”, e così via. Le parole venivano pronunciate a fatica e dimenticate subito dopo, e io non riuscivo a trattenere il sorriso: l’approccio puramente formale all’insegnamento, in certi casi, non è soltanto dannoso — è semplicemente inutile. Da qui, probabilmente, nascono anche quelle rare critiche che ho sentito: che al corso sono state assegnate troppe ore e non è chiaro come impiegarle tutte con gli studenti. Alcuni dicevano perfino che sarebbe stato meglio aumentare le ore dedicate alla storia della Russia.
Nel nostro dipartimento non era consuetudine discutere gli approcci didattici. A volte parlavamo di singoli compiti che assegnavo ai miei studenti, ma un confronto metodologico più ampio non si sviluppava mai. Non so esattamente perché. Forse perché ogni docente ha il proprio stile, e ciò che funziona per uno può risultare del tutto inefficace per un altro.
Sono convinta che il corso di Fondamenti della statualità russa possa essere condotto in molti modi diversi — anche in modi diversi dal mio — e risultare comunque davvero utile per gli studenti. A mio avviso, la qualità dell’insegnamento non risiede in dispense o schemi precompilati, frutto del cosiddetto “scambio di esperienze”, bensì nella volontà autentica di fare bene, nella libertà interiore e nell’integrità professionale, che permettono di sperimentare e al tempo stesso di sentire la propria responsabilità.
Certo, vedendomi correre su e giù per i piani con tutta la mia attrezzatura, alcuni mi consigliavano di assegnare esercizi che non richiedessero il supporto multimediale, e di arrivare in ritardo all’inizio delle lezioni per avere almeno il tempo di mangiare qualcosa. Dunque, se non altro, una cosa sul mio metodo era nota a tutti: era scrupoloso.
Promozione garantita, indipendentemente dalle conoscenze
Nel corso del tempo, molti studenti hanno realmente ampliato le proprie conoscenze. Il segreto era semplice: fin dall’inizio ho preso questo corso sul serio, come qualunque altro, e gli studenti lo percepivano, facendosi coinvolgere da questo atteggiamento. Di fatto, non avevo molta scelta: dover tenere undici lezioni identiche alla settimana, ascoltando relazioni scaricate da Internet, sarebbe stato per me insostenibile. Gli studenti, di norma, si preparavano con cura; se non lo facevano, sapevano che non sarebbe bastato cavarsela con superficialità. Sarebbero comunque stati chiamati a lavorare — solo in una modalità diversa, che avrei scelto io per loro. Per ogni possibile caso di impreparazione avevo un piano di riserva, sempre pensato in anticipo. Un discorso a parte merita la verifica intermedia. Dal dipartimento ci venne data una direttiva molto chiara: attribuire il superamento del corso a tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza. So di casi in cui sono stati certificati studenti che non parlavano nemmeno il russo. Non era possibile essere respinti: l’unica eccezione era l’assenza all’ultima lezione. In quel caso, sì, si poteva risultare “non idonei”.
P.S.
Ricordo perfettamente il primo giorno della guerra all’Ucraina. Entrai in università e sentii subito che l’atmosfera era cambiata. Nei corridoi si affollavano gli studenti, animatamente impegnati a discutere le ultime notizie. Anche tra i colleghi del dipartimento si percepiva agitazione. Ovviamente, tutti erano sotto shock, e ciascuno lo esprimeva a modo proprio. C’era chi si mostrava sconvolto per le vittime che il conflitto avrebbe causato; chi ostentava sicurezza, affermando di aver previsto tutto e persino di aver preparato in anticipo gli studenti; chi sperava in una rapida conclusione della guerra.
Va detto, però, che nei primi giorni — forse settimane, o addirittura mesi — non giunsero direttive ufficiali dalla direzione. Nessuna istruzione su come parlare della guerra agli studenti, su cosa dire o su come interpretare quanto stava accadendo. Si sentiva solo una raccomandazione generica: proseguire l’attività didattica come di consueto e invitare gli studenti a trovare stabilità nelle occupazioni quotidiane, nello studio.
In fondo, era un consiglio sensato — almeno nei primi giorni. Con una riserva: la dirigenza, molto probabilmente, contava sul fatto che i discorsi sulla guerra si sarebbero semplicemente estinti, e che gli studenti avrebbero fatto finta che nulla fosse successo. Ma questo, com’era ovvio, era impossibile.
In quel periodo insegnavo a studenti dei corsi avanzati delle facoltà umanistiche. Mi facevano molte domande. Quando uno di loro chiese esplicitamente: «Lei è favorevole o contraria?», risposi onestamente che ero contraria. A interrogativi più profondi, in quel momento, non ero in grado di rispondere. Anch’io ero paralizzata, confusa, incapace di comprendere a fondo quanto stava accadendo. Eppure, non cercavo di troncare in fretta le discussioni. Al contrario, lasciavo spazio agli studenti, permettendo loro di parlare, di condividere pensieri ed emozioni. Era evidente che ne sentivano il bisogno.
Forse era una questione di età, forse della maggiore preparazione teorica, forse del momento drammatico in sé, ma quegli studenti iniziarono presto a formulare una propria posizione. Alcuni sostenevano la guerra, altri vi si opponevano. Cercavano di argomentare il loro punto di vista.
Ma in breve tempo queste discussioni iniziarono a diminuire. Era ormai chiaro quale linea di condotta ci si aspettava da tutti, all’interno dell’università e dei dipartimenti.
Cominciarono a moltiplicarsi disposizioni spiacevoli e talvolta assurde — sia per i docenti, sia per gli studenti. Ricordo bene quando un giorno arrivai in dipartimento e trovai sulla scrivania un modulo già compilato a mio nome, con cui “chiedevo volontariamente” di trattenere una parte del mio stipendio a favore dei combattenti della “Operazione militare speciale”. Occorreva solo firmare. Ce n’erano intere pile, precompilate “per conto” di ciascun docente. Mi colpì la rapidità con cui i colleghi avevano aderito all’iniziativa e la loro prontezza nel seguire tali istruzioni senza la minima esitazione.
Ricordo anche quando ai tutor delle classi studentesche fu imposto di accompagnare gli studenti a vari eventi dedicati alla guerra — ad esempio, a una mostra in onore degli “eroi”. Anch’io ero tutor, ma i miei studenti non andarono da nessuna parte.
Gradualmente, si intensificò anche il controllo. Ai tutor fu chiesto di monitorare le pubblicazioni degli studenti sui social network e nei gruppi di messaggistica. Ricordo una docente che mi raccontava con preoccupazione di come alcuni studenti scegliessero nickname o immagini del profilo su Telegram che “discreditavano l’esercito” o “violavano i valori tradizionali”. Rimasi colpita da quanto si fosse disposti a spingersi nel controllo della vita privata degli studenti.
E “la ciliegina sulla torta” furono i privilegi che, col tempo, cominciarono ad accumularsi per i figli dei combattenti. All’università si instaurò una regola non scritta: quegli studenti non potevano essere espulsi — per quanto si impegnassero a rendersi irreprensibili in tal senso. Gli studenti lo capirono in fretta e cominciarono a sfruttarlo. A volte bastava dichiarare che uno zio o un cugino era al fronte, e già era sufficiente. Si arrivava all’assurdo. Ma nessuno veniva espulso.
(“Proekt Republic” è un sito di informazione indipendente dichiarato “agente straniero” dal governo russo. L’originale è disponibile qui https://republic.ru/posts/115589?utm_source=republic.ru )