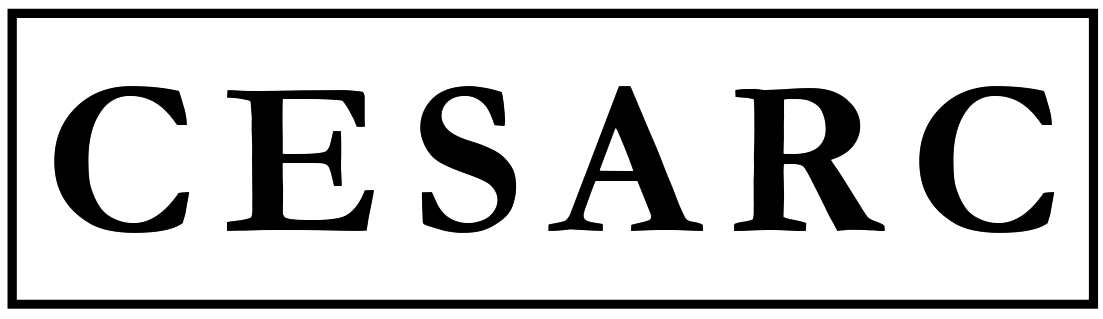Gevorg Melikyan

Nel complesso panorama della geopolitica globale contemporanea, mentre il vecchio ordine mondiale sta morendo[1] e le potenze non occidentali sfidano sempre più l’ordine internazionale basato sulle regole esistenti[2], le piccole nazioni si trovano nel mirino della competizione strategica tra le grandi potenze, costrette ad adottare “strategie di sopravvivenza”[3]. L’Armenia, uno Stato piccolo ma strategicamente significativo nel Caucaso meridionale, incarna le sfide e le minacce esistenziali affrontate dalle nazioni che cercano di orientarsi in queste acque turbolente, dove la politica di potenza e l’uso della forza sono tornati a essere elementi centrali delle relazioni internazionali[4]. Le pressioni, sia interne che esterne, per compiere una svolta irreversibile verso l’Occidente o per mantenere una stretta alleanza con la Russia sono diventate una caratteristica determinante del contesto di politica estera e di sicurezza dell’Armenia, sollevando interrogativi sulla sua sovranità, sulla sua autonomia strategica e sulla sua stabilità a lungo termine. Questo articolo esamina le implicazioni di tale dicotomia, critica la tendenza delle grandi potenze a imporre scelte binarie alle nazioni più piccole e sostiene la necessità di un approccio equilibrato e su misura nelle politiche estera e di sicurezza dell’Armenia.
L’Armenia tra imperi: sfide post-coloniali
Il dilemma geopolitico dell’Armenia è profondamente radicato nella sua storia di crocevia tra civiltà diverse[5]. Situata all’incrocio tra Europa e Asia, il paese è stato perennemente un campo di battaglia per imperi in cerca di controllo su rotte commerciali strategiche, risorse e influenza nella regione. Il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 rappresentò un punto di svolta per l’Armenia, offrendole la possibilità di riconquistare l’indipendenza dopo decenni di dominio sovietico. Tuttavia, sin dall’inizio, l’Armenia si ritrovò in uno stato di guerra: azioni ostili da parte dell’Azerbaigian, sostenute da Mosca, portarono a un conflitto su vasta scala nella regione del Nagorno-Karabach, abitata da una popolazione etnicamente armena[6]. Questa situazione di guerra continua ha gravemente compromesso le condizioni di partrenza dell’Armenia, aggravando le sue sfide geopolitiche e sistemiche. Circondata da vicini ostili – Turchia e Azerbaigian – che hanno imposto un blocco economico al paese, e accrescendo al contempo la propria dipendenza strategica dalla Russia, l’Armenia si è trovata nella posizione estremamente precaria di punto focale per gli interessi contrastanti delle grandi potenze globali. La Russia, attore dominante nella regione e “protettore” storico dell’Armenia, considera il paese un elemento fondamentale della propria sfera d’influenza. Attraverso la sua alleanza strategica con l’Armenia, la leva economica e l’elevato volume degli scambi commerciali, nonché la presenza di una base militare russa sul territorio armeno e delle guardie di frontiera dell’FSB ai confini con l’Iran e la Turchia, Mosca si è consolidata come attore indispensabile nel panorama politico ed economico dell’Armenia. Questa dipendenza, insieme a oltre 300 accordi ufficiali firmati tra Armenia e Russia, limita fortemente la capacità dell’Armenia di diversificare le proprie opzioni in materia di politica estera e di sicurezza, poiché un allontanamento da Mosca potrebbe provocare ripercussioni negative e potenziali ritorsioni da parte della Russia. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno cercato di espandere la propria influenza nel Caucaso meridionale come parte di una strategia più ampia volta a controbilanciare il dominio russo. L’Armenia viene spesso osservata attraverso il prisma di questa rivalità strategica, con le potenze occidentali che promuovono riforme democratiche, aiuti economici e l’integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche come contrappeso al controllo esercitato dalla Russia.
Le vulnerabilità geopolitiche dell’Armenia sono ulteriormente aggravate da vincoli economici e finanziari di natura sistemica. La sua economia, di piccole dimensioni e senza sbocchi sul mare, è altamente sensibile agli shock esterni, il che la rende dipendente da qualsiasi forma di aiuto straniero e dalle rimesse provenienti dalla sua vasta diaspora. La limitata base industriale del paese e l’eccessiva dipendenza da pochi settori, come quello minerario, ostacolano ulteriormente la sua capacità di sviluppare politiche economiche autonome. Queste debolezze rendono l’Armenia un obiettivo allettante – se non addirittura uno Stato cliente – per la Russia, poiché la leadership armena è costretta a dare priorità alla sopravvivenza immediata piuttosto che alla pianificazione strategica a lungo termine.
Ad esempio, nonostante le numerose dichiarazioni relative ad un cambiamento dell’orientamento della politica estera armena verso l’Occidente, il commercio bilaterale tra Armenia e Russia è aumentato vertiginosamente dalla scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. Gli imprenditori armeni hanno approfittato delle sanzioni occidentali contro Mosca per riesportare in Russia[7] molti beni prodotti in Occidente, oltre a oro e diamanti[8]. Nel contesto delle recenti tensioni tra l’Occidente e la Russia, l’Armenia ha cercato di triplicare le esportazioni verso la Russia in un periodo di dieci mesi, raggiungendo quasi 8,3 miliardi di dollari nel 2024[9], fornendo anche supporto per aiutare Mosca ad aggirare le sanzioni – fatto che ha ulteriormente approfondito la sua dipendenza da Mosca.
In questo contesto altamente conteso, in cui lo spazio di manovra della politica estera armena è sempre stato limitato da un vicinato difficile e dalla contrapposizione tra Occidente e Russia in Eurasia[10], l’esposizione dell’Armenia a pressioni geopolitiche, economiche e finanziarie concorrenti la rende particolarmente vulnerabile. Le rivalità tra Russia, Occidente e, in una certa misura, anche la Cina, restringono ulteriormente le capacità di manovra dell’Armenia, dove qualsiasi passo falso potrebbe comportare gravi ripercussioni o conseguenze fatali. Che si tratti di gestire alleanze militari, assicurare rotte commerciali o amministrare gli aiuti esteri, la capacità dell’Armenia di tracciare un percorso indipendente resta fortemente limitata dai suoi vincoli sistemici e dalla più ampia competizione strategica che attraversa la regione.
L’Armenia come crocevia strategico
La Russia è da tempo considerata il principale garante della sicurezza dell’Armenia, secondo documenti strategici firmati negli anni Novanta. L’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, un’alleanza militare guidata dalla Russia, e la presenza di truppe russe in Armenia confermano questa relazione. Tuttavia, il ruolo della Russia non è stato privo di controversie, in particolare alla luce della sua apparente inattività durante le offensive militari dell’Azerbaigian in Nagorno-Karabach a partire dal settembre 2020. Ciò ha alimentato un crescente scetticismo all’interno dell’Armenia riguardo all’affidabilità della Russia come partner strategico.
D’altro canto, l’Occidente ha cercato di rafforzare i legami con l’Armenia attraverso iniziative come il Partenariato Orientale, l’Accordo di Partenariato Globale e Rafforzato, e l’aumento degli aiuti economici e allo sviluppo. Sebbene questi sforzi offrano potenziali benefici, hanno cominciato a essere accompagnati da aspettative implicite o esplicite di un riallineamento politico o di una posizione apertamente anti-russa. Una più profonda integrazione con le istituzioni occidentali implicherebbe l’adozione di politiche che potrebbero mettere a dura prova le relazioni con la Russia. “L’Occidente dovrebbe evitare di inquadrare il proprio coinvolgimento con gli Stati piccoli come una competizione a somma zero con la Russia” – ha affermato Eduard Abrahamyan – dove gli sforzi dell’Armenia per diversificare le proprie relazioni internazionali vengono percepiti come una minaccia o come un atto inaccettabile da una parte o dall’altra”.
I rischi di una scelta binaria
Le scelte in materia di politica estera e di sicurezza sono fondamentali per la stabilità dell’Armenia, a causa della sua precaria posizione geopolitica. Errori strategici – come una dipendenza eccessiva dalla Russia, una profonda esposizione in termini di sicurezza verso l’Azerbaigian, o l’incapacità dell’Armenia di adattarsi alle dinamiche regionali in evoluzione e di influenzare efficacemente il proprio ambiente – potrebbero aggravare le sue vulnerabilità, portando a stagnazione economica, isolamento o persino all’escalation di conflitti, con la perdita di ulteriori territori, se non della sovranità stessa.
La capacità di determinare in modo indipendente le proprie politiche estera e di sicurezza, senza il rischio di ritorsioni da parte di grandi potenze, dovrebbe costituire un pilastro della statualità delle piccole nazioni. Quando attori esterni esercitano pressioni indebite, minano di fatto la sovranità e la dignità delle piccole nazioni, relegandole al ruolo di pedine in una più ampia lotta geopolitica. Per l’Armenia, essere costretta a stringere alleanze esclusive amplifica ulteriormente le sue vulnerabilità. Allinearsi troppo strettamente a una sola potenza comporta il rischio di alienarsi l’altra, con conseguenze potenzialmente gravi come sanzioni economiche, isolamento politico o addirittura minacce militari. Ad esempio, una svolta verso l’Occidente potrebbe spingere la Russia ad adottare misure punitive, come la limitazione delle forniture energetiche o l’indebolimento della sicurezza armena attraverso una serie di campagne militari, sia palesi che occulte. Al contrario, mantenere una dipendenza eccessiva dalla Russia limita la capacità dell’Armenia di perseguire la modernizzazione economica e le riforme democratiche che l’impegno con l’Occidente potrebbe facilitare.
Un rischio ulteriore e significativo è rappresentato dalla possibilità di alimentare la polarizzazione interna. La società armena non è monolitica, e un approccio deterministico alla politica estera e di sicurezza potrebbe contribuire ad approfondire le divisioni esistenti. La scelta binaria imposta dagli attori esterni spesso amplifica queste fratture, creando un terreno fertile per l’instabilità politica. Ciò indebolisce ulteriormente la capacità della nazione di affrontare in modo efficace le sfide interne e internazionali più urgenti.
Ad esempio, nella società armena esistono opinioni e posizionamenti controversi riguardo alla recente decisione del paese di firmare la carta istitutiva della Commissione di Partenariato Strategico USA-Armenia[11]. Mentre alcuni considerano questa mossa come un passo verso un rafforzamento dei legami con l’Occidente, altri sostengono che essa sia carente di garanzie concrete in materia di sicurezza, lasciando l’Armenia esposta a potenziali ritorsioni da parte della Russia. Azioni simili intraprese dalla Georgia e dall’Ucraina — nel tentativo di allinearsi più strettamente all’Occidente senza assicurarsi solidi quadri di sicurezza — hanno provocato conseguenze gravi, comprese guerre. L’Armenia rischia di ripetere questi errori, intraprendendo passi simbolici che potrebbero irritare Mosca pur offrendo benefici strategici limitati.
Un’altra recente iniziativa che ha contribuito ad accentuare ulteriormente la polarizzazione della società è stata la decisione del governo armeno di dare il via libera a un disegno di legge per avviare il processo di adesione all’Unione Europea[12] — una mossa che alcuni critici percepiscono come una tattica populista volta a ottenere consensi elettorali. Sebbene un possibile allineamento con l’Occidente o con l’UE rappresenti un passo estremamente importante per una giovane democrazia come l’Armenia, la rinascita della politica di potenza e l’uso della forza o di ritorsioni economiche nelle relazioni internazionali potrebbero aumentare, anziché ridurre, le vulnerabilità del Paese. È probabilmente per questo che il Ministro dell’Economia armeno ha rapidamente chiarito che il governo non ha intenzione di ritirarsi dall’Unione Economica Eurasiatica[13] — una decisione che renderebbe impossibile l’adesione all’UE.
Nel dilemma binario tra Russia e Occidente, cambiamenti di orientamento come questi, se non accompagnati da autentici benefici in termini di sicurezza, potrebbero essere altrettanto pericolosi. Il rischio non consiste solo nell’irritare una delle due parti, ma anche nel predisporre l’Armenia a uno squilibrio strategico che la renderebbe vulnerabile sia a pressioni esterne — come un nuovo attacco militare da parte dell’Azerbaigian con il benestare della Russia — sia all’assenza di un percorso chiaro verso una sicurezza sostenibile o una prosperità economica duratura.
La necessità di un approccio equilibrato e su misura
La stabilità e lo sviluppo a lungo termine dell’Armenia dipendono dalla sua capacità di navigare nella competizione tra grandi potenze senza soccombere alle pressioni delle scelte binarie. Un approccio equilibrato e su misura nelle politiche estera e di sicurezza rappresenta un percorso praticabile, che consente all’Armenia di impegnarsi in modo costruttivo sia con l’Occidente che con la Russia, tutelando al contempo i propri interessi nazionali. Tale approccio richiede una comprensione sfumata delle motivazioni e delle strategie delle grandi potenze.
Ad esempio, mentre la Russia vede l’Armenia come un elemento critico della propria sfera d’influenza, l’Occidente la considera un potenziale alleato nella promozione dei valori democratici e nel contrasto all’autoritarismo. L’Armenia deve modellare le proprie strategie in modo da allinearsi con le sue specifiche realtà geopolitiche, sfruttando a proprio vantaggio queste diverse prospettive. Attraverso un’attenta calibrazione dei propri rapporti, l’Armenia può ottenere benefici concreti da entrambe le parti, evitando di diventare bersaglio di una o dell’altra.
Lezioni da alcune nazioni post-coloniali
L’Armenia può trarre preziose lezioni da altri paesi che sono riusciti a gestire con successo dilemmi simili. Paesi come Singapore hanno dimostrato l’importanza del pragmatismo strategico. Nonostante le sue ridotte dimensioni e la mancanza di risorse naturali, Singapore è riuscita a mantenere relazioni equilibrate con grandi potenze come gli Stati Uniti e la Cina, dando priorità alla resilienza economica, alla flessibilità diplomatica e a una solida postura difensiva. Questi esempi sottolineano la fattibilità di un approccio equilibrato, anche per gli Stati di piccole dimensioni che operano in contesti geopolitici complessi.
Un altro esempio è Israele, una piccola nazione del Medio Oriente che ha saputo navigare con successo tra le complessità della geopolitica regionale e globale. Pur essendo circondata da vicini ostili e affrontando minacce alla sicurezza costanti e profonde asimmetrie, Israele ha costruito un settore della difesa robusto, sviluppato tecnologie d’avanguardia e coltivato alleanze strategiche e interdipendenze con le grandi potenze, inclusi gli Stati Uniti. La capacità di Israele di bilanciare la forza militare con la flessibilità diplomatica le ha consentito di mantenere sovranità e sicurezza in una regione instabile.Inoltre, il suo focus sull’innovazione e sull’autosufficienza le ha permesso di trasformare potenziali vulnerabilità in risorse, posizionandosi come un modello intelligente e di successo per le nazioni più piccole che devono affrontare scenari geopolitici difficili[14].
L’esperienza della Georgia rappresenta un monito per l’Armenia.
In seguito alle sue aspirazioni di adesione alla NATO e all’Unione Europea, la Georgia ha dovuto affrontare una pressione costante da parte della Russia, culminata nella guerra del 2008. Sebbene l’allineamento della Georgia con l’Occidente abbia aperto la strada allo sviluppo economico e istituzionale, ha anche lasciato il paese in una situazione di sicurezza precaria, con parte del suo territorio occupato e le sue ambizioni di adesione alla NATO bloccate. Ciò sottolinea i rischi che corrono le nazioni più piccole nell’allinearsi troppo strettamente a un solo blocco, soprattutto quando tali mosse non solo non conducono all’ingresso nell’UE o nella NATO, ma provocano anche una forte ostilità da parte della Russia. D’altro canto, l’enfasi posta dalla Georgia sulla diplomazia pubblica e sul soft power come strumento per ottenere supporto internazionale offre spunti preziosi. Attraverso iniziative diversificate e il focus sulle riforme democratiche, il paese ha cercato di assicurarsi consistenti aiuti esteri e rafforzare la propria diversificazione economica e lo sviluppo.
L’Ucraina rappresenta invece l’esempio doloroso di una nazione vittima della rivalità strategica tra Russia e Occidente. Dal 2014, l’Ucraina ha subito le devastanti conseguenze dell’essere rimasta intrappolata in questo fuoco incrociato geopolitico, dove le sue aspirazioni democratiche e il desiderio di un’integrazione più stretta con le strutture euro-atlantiche sono stati accolti con aggressioni militari e violazioni territoriali da parte della Russia.L’annessione della Crimea e la guerra in corso rappresentano non soltanto una lotta per il controllo territoriale, ma una palese soppressione del diritto sovrano dell’Ucraina di determinare il proprio futuro. Questo scontro di interessi strategici ha trasformato l’Ucraina in un campo di battaglia tra visioni contrastanti di governo e di influenza, con i cittadini comuni finiti a pagare il prezzo più alto. La guerra ha inflitto un tributo devastante: centinaia di migliaia di vite perse, milioni di persone sfollate e un’economia nazionale profondamente segnata. Nonostante che la lotta dell’Ucraina per la democrazia e l’avvicinamento all’Occidente sia coraggiosa e sincera, la sua attuale condizione mette in evidenza i limiti della solidarietà internazionale di fronte all’impiego spietato della forza militare. La tragedia geostrategica e umana dell’Ucraina sottolinea i pericoli insiti nell’uso delle nazioni più piccole come teatri di antagonismo tra grandi potenze, dove le legittime aspirazioni all’autodeterminazione e alla riforma democratica vengono oscurate dalla più ampia competizione per l’influenza globale. In questo contesto, la sofferenza dell’Ucraina rappresenta un cupo monito: le rivalità geopolitiche, se lasciate senza controllo, possono ridurre le vite umane e le aspirazioni nazionali a semplici danni collaterali nella corsa alle ambizioni egemoniche.
Uno degli insegnamenti più significativi che ci vengono dall’esperienza ucraina è la sua capacità di mobilitare il sostegno internazionale di fronte all’aggressione. L’Ucraina ha saputo utilizzare in modo efficace la propria diaspora, i media e i canali diplomatici per evidenziare la propria condizione e ottenere aiuti e sostegno politico da parte dell’Occidente. L’Armenia potrebbe replicare questo approccio, coinvolgendo attivamente la propria diaspora globale e rafforzando la propria capacità di comunicare alla comunità internazionale le sfide geopolitiche che si trova ad affrontare. Allo stesso tempo, il caso ucraino mette in evidenza la necessità di evitare una dipendenza eccessiva dal supporto straniero, che spesso è accompagnato da condizioni vincolanti e non garantisce stabilità a lungo termine.
Conclusione
Le sfide geopolitiche dell’Armenia sono emblematiche di una questione più ampia nelle relazioni internazionali: la tendenza delle grandi potenze a strumentalizzare le piccole nazioni nella loro competizione strategica. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea devono riconoscere i pericoli legati allo sfruttamento delle aspirazioni e delle vulnerabilità di Stati più piccoli, come l’Armenia, per alimentare l’antagonismo verso avversari come la Russia — soprattutto quando né gli USA né l’UE sono disposti a offrire garanzie concrete di sicurezza in caso di aggressione. Questa pratica non solo mina la sovranità di tali nazioni, ma destabilizza intere regioni, perpetuando cicli di insicurezza e di ulteriore dipendenza. I decisori politici occidentali si avvicinano alle relazioni con le piccole nazioni attraverso la lente di una competizione a somma zero con la Russia, trattando questi Stati come semplici strumenti per raggiungere i propri obiettivi strategici. Così facendo, ignorano le complesse realtà sul campo e i costi enormi che tali politiche impongono alle nazioni intrappolate nel mezzo. Le “richieste” di un allineamento immediato con le norme e le politiche occidentali spesso trascurano i limiti temporali, le risorse e le riforme strutturali necessarie per transizioni efficaci. L’Armenia, come molte altre piccole nazioni, non possiede la resilienza sistemica per affrontare tali cambiamenti senza rischiare gravi disordini sociali ed economici.
Il caso della Georgia evidenzia in modo netto i fallimenti di questo approccio. Nonostante oltre due decenni di sforzi autentici per allinearsi ai valori e alle norme europee, la Georgia rimane al di fuori del quadro istituzionale dell’UE. Questo ritardo non solo alimenta la frustrazione nella popolazione, ma indebolisce anche le fazioni filo-occidentali del Paese, creando opportunità per la Russia di sfruttare il malcontento. Allo stesso modo, le aspirazioni di lunga data dell’Ucraina per l’adesione alla NATO e all’UE sono state accolte con esitazioni e incoerenze da parte dei leader occidentali, consentendo alla Russia di approfittare dell’ambiguità per intensificare la propria aggressione. Questi esempi evidenziano come la riluttanza dell’Occidente a offrire impegni chiari e concreti finisca per minare proprio quegli Stati che intende sostenere.
I decisori politici occidentali dovrebbero sottrarsi alla pratica di inquadrare le relazioni con le piccole nazioni come prerequisito per l’antagonismo nei confronti della Russia. Questo approccio costringe paesi come l’Armenia a dilemmi esistenziali, in cui qualsiasi tentativo di un coinvolgimento significativo con l’Occidente rischia di provocare ritorsioni da parte di Mosca e provocazioni militari da parte dell’Azerbaigian. Tali politiche aggravano le divisioni, erodono la fiducia e destabilizzano le regioni, finendo per non servire né gli interessi degli Stati più piccoli né quelli dell’Occidente. L’UE e gli Stati Uniti devono invece adottare strategie più morbide e attentamente calibrate di “uscita dal dominio russo”, dando priorità a una reale crescita economica, al commercio, all’istruzione, allo sviluppo istituzionale e alla stabilità interna dei loro partner, fornendo loro gli strumenti per orientare in modo efficace le proprie strategie, piuttosto che costringerli a scelte binarie immediate.
Per l’Armenia, ciò significherebbe sostenere riforme sistemiche reali — e non di facciata — a un ritmo sostenibile, offrire incentivi economici e politici coerenti e astenersi dal creare condizioni che approfondiscano le sue vulnerabilità rispetto alle pressioni esterne.
L’Occidente deve dimostrare che le sue partnership si basano su una cooperazione genuina e su benefici reciproci, e non su relazioni concepite come terreno di scontro tra grandi potenze. L’Armenia, dal canto suo, dovrebbe essere libera dall’influenza unilaterale di qualsiasi grande potenza, che si tratti della Russia o dell’Occidente. Il suo percorso deve puntare alla stabilità economica e all’autosufficienza, anche se ciò rappresenta un viaggio estremamente difficile. La sovranità dell’Armenia non deve dipendere dai capricci degli Stati più grandi, e la sua capacità di orientarsi tra le complessità delle relazioni internazionali dovrebbe fondarsi sulla propria forza e resilienza, non sull’essere legata a un’agenda straniera.
La mancata comprensione degli errori del passato — propri o altrui — rischia di perpetuare un ciclo pericoloso, in cui le piccole nazioni vengono ridotte a pedine in un più ampio gioco geopolitico. Le lezioni della Georgia, dell’Ucraina e ora dell’Armenia dovrebbero spingere gli Stati Uniti e l’UE a ripensare le loro strategie, rendendole più contestuali e orientandosi verso politiche che valorizzino l’autonomia e la sovranità degli Stati più piccoli senza provocare Stati maligni. Quanto alla Russia, il suo approccio provocatorio, aggressivo, dittatoriale e antidemocratico non fa che esasperare le tensioni e destabilizzare le regioni. Tuttavia, la questione fondamentale su quali siano le migliori strategie e tattiche da adottare nei rapporti con la Russia resta ancora senza risposta…
Gevorg Melikyan è professore di Politica internazionale presso l’istituto Universitario Armeno di Politica estera e di sicurezza. Ha fondato l’Istituto Armeno per la Statualità e la Resilienza ed è stato consigliere ufficiale del Presidente della Repubblica Armena Armen Sarkissian (2018-2022).
[1] https://www.thenation.com/article/archive/imperial-decline-china-france-russia/
[2] https://lordslibrary.parliament.uk/challenges-to-a-rules-based-international-order/
[3] www.researchgate.net/publication/323135839_Security_Strategies_of_Small_States_in_a_Changing_World
[4] E. Abrahamyan, “Small States, Russia and the West: Polarity, Constellations and Heterogeneity, in the Geopolitics of the Caucasus”, Routledge 2025.
[5] https://www.president.am/en/press-release/item/2019/09/15/Sheikha-Hussah-Sabah-al-Salem-al-Sabah-in-Armenia/
[6] https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer
[7] https://massispost.com/2024/12/trade-turnover-between-russia-and-armenia-doubles-to-10-2-billion/
[8] https://hetq.am/en/article/171035
[9] https://www.azatutyun.am/a/33247573.html
[10] https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-03-14-Armenia3.pdf
[11] https://www.state.gov/office-of-the-spokesperson/releases/2025/01/secretary-antony-j-blinken-and-armenian-foreign-minister-ararat-mirzoyan-at-a-strategic-partnership-commission-charter-signing-ceremony
[12] https://en.armradio.am/2025/01/09/armenian-government-greenlights-bill-on-eu-membership/
[13] https://www.civilnet.am/en/news/812088/no-plans-to-leave-eaeu-despite-armenias-eu-aspirations-economy-minister/
[14] Da un’analisi di Amit Assa, colonnello in pensione dell’intelligence israeliana (Isa-Shabak) con oltre 35 anni di esperienza nel contrasto al terrorismo.